Gli standard operativi per una corretta Gestione degli SME
SONIA ROSOLEN* E FRANCESCO ROSSI**
Il monitoraggio in continuo delle emissioni soggette ai criteri previsti nell’Allegato VI della Parte V D.Lgs. 152/2006 e s.m.i riveste notevole importanza nel panorama della gestione degli impatti emissivi industriali. Basti pensare che i grandi impianti di combustione, gli impianti di incenerimento e coincenerimento, gli impianti di recupero anche energetico di rifiuti e gli impianti che trattano rifiuti e combustibili derivanti da rifiuti ammessi a beneficiare del regime previsto per le fonti rinnovabili sono solo alcune delle tipologie di impianto sottoposti obbligatoriamente ai Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (cd. SME). Peraltro, in caso di determinate criticità emissive, tali sistemi di controllo possono comunque essere imposti a qualsiasi tipologia di impianto.
Strutturato come attività in autocontrollo, il monitoraggio svolto sotto il governo continuo e diretto del Gestore impone una modalità di raccolta ed elaborazione delle rilevazioni condivisa e una puntuale conservazione, per poter superare positivamente possibili contestazioni da parte degli Organi di Controllo.
L’indiscussa validità dei dati ottenuti attraverso un monitoraggio in autocontrollo è infatti ancora oggi oggetto di ampie critiche, ancorché tale modalità di verifica costituisca uno dei pilastri della politica comunitaria di enforcement e sia ampiamente diffusa, già da alcuni anni, a livello nazionale attraverso la previsione di piani di autocontrollo nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (cd. AIA). Per garantire una maggiore affidabilità del dato, rilevato e elaborato, è pertanto necessario porre particolare attenzione alle diverse fasi di gestione degli SME e condividere, se possibile, con le varie Autorità, dei protocolli operativi.
Proprio con il duplice scopo di fornire supporto ai Gestori di impianti soggetti allo SME e di costituire uno standard di riferimento che faciliti le verifiche da parte delle Enti di Controllo, ISPRA ha elaborato la Guida tecnica per i gestori dei Sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera, il cui aggiornamento è stato pubblicato a luglio di quest’anno (Rev. 6 del 4 ottobre 2012, Manuali e linee guida 87/2013).
Altro utile e recente riferimento tecnico per i Gestori di impianti SME, quantomeno per gli impianti toscani, è rappresentato dal protocollo, realizzato da ARPAT e CISPEL, concernente le modalità applicative dell’elaborato ISPRA.
L’adozione di norme tecniche di riferimento ed in particolare di un Manuale di Gestione quale protocollo condiviso per la corretta gestione degli SME è molto importante perché permette ai Gestori e agli Enti di controllo di condividere un nucleo di procedure operative, la cui adozione rende di fatto dimostrabile la qualità e l’affidabilità del dato rilevato ancorché ottenuto attraverso un sistema di monitoraggio in autocontrollo.
La Guida Tecnica ISPRA
Il 26.10.2011 ISPRA ha emanato la prima versione della Guida tecnica per i gestori degli SME, provvedendo a stabilire i criteri base per la realizzazione di un protocollo condiviso per la gestione dello SME tra Enti di Controllo e Gestori, attraverso l’applicazione di norme tecniche CEN di riferimento, operativamente attivate per mezzo di un Manuale di Gestione (MG).
La Guida Tecnica si poneva come obiettivo quello di fornire utili elementi per l’applicazione operativa della norma UNI EN 14181:2005 – norma avente ad oggetto l’utilizzo della strumentazione di misura e non l’elaborazione dei dati – cercando di rendere omogenee e semplici le modalità di elaborazione, attraverso la definizione di un criterio unico per tutti gli impianti1.
L’edizione aggiornata, pubblicata a luglio di quest’anno, ha introdotto, rispetto alla precedente, importanti novità, sia a livello formale che sostanziale, volte, da un lato, a rafforzare l’affidabilità del dato e, dall’altro, a semplificare alcuni passaggi contenuti nell’edizione precedente.
Le modifiche apportate riguardano principalmente:
• alcune definizioni operative2 (tra le quali si ricorda la riformulazione del cd. dato elementare3);
• l’aggiornamento alle norme internazionali di riferimento4;
• l’aggiornamento delle modalità di scelta e di gestione dei campi di misura strumentali5;
• la definizione degli intervalli di confidenza per alcuni parametri di riferimento e per alcuni inquinanti6;
• la gestione operativa e documentale dello SME ai sensi della UNI EN 14181:20057.
Il Protocollo Operativo ARPAT-CISPEL
Il suddetto protocollo, sviluppato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana e CISPEL, Associazione delle imprese di servizio pubblico, nell’ambito delle rispettive competenze, interviene specificando tempi e modalità di applicazione della Guida Tecnica ISPRA e di adeguamento degli SME, affrontando, oltre alla gestione della fasi di interruzione dell’alimentazione e dello spegnimento dell’impianto, anche aspetti non strettamente connessi agli SME8.
Nel delimitare il proprio campo di applicazione, il Protocollo prevede inoltre specifiche disposizioni per gli impianti di incenerimento RU, RS da rifiuti urbani, rifiuti sanitari e fanghi di depurazione a ciclo continuo.
Come chiarito con Circolare del Direttore Tecnico di ARPAT n. 5 del 30.4.2013, tale documento rappresenta per ARPAT un valido strumento di riferimento nella stesura dei pareri elaborati come supporto alle Autorità di Controllo, in quanto fornisce indicazioni circostanziate sulla modalità di gestione degli SME in conformità alla UNI EN 14181:2005.
L’importanza del rispetto degli standard tecnici di riferimento
Il rispetto degli attuali standard tecnici di riferimento è determinante per poter efficacemente dimostrare la gestione in qualità dello SME e quindi la piena affidabilità dei dati rilevati, superando così possibili atteggiamenti di diffidenza nei confronti dei risultati ottenuti attraverso i sistemi di monitoraggio in autocontrollo. Se la qualità del dato può infatti essere influenzata in moltissimi modi già a partire dalla fase di progettazione dello SME, fissare i presupposti di rilevazione ed elaborazione non può che “oggettivizzare” il risultato finale.
Attraverso il rispetto di standard operativi, se da un lato si riduce enormemente l’area di discrezionalità del Gestore, dall’altro si tutela colui che decida di uniformarsi alle linee guidata, attraverso il rafforzamento della qualità e dell’affidabilità dei dati ottenuti.
Ciò premesso, date le recenti indicazioni operative fornite da ISPRA, ma anche da ARPAT e CISPEL ed in considerazione della nuova direttiva 2010/75/UE in tema di emissioni industriali9, non si può che invitare i Gestori degli SME ad attuare un assessment interno per verificare se le proprie procedure gestionali siano conformi o debbano essere in parte riviste alla luce degli standard tecnici di riferimento pubblicati nel corso degli ultimi mesi.
* Avvocato in Vicenza
** Ingegnere, StudioGNS di Padova
1 A tal fine ha imposto:
i. l’utilizzo dei dati istantanei acquisiti dal sistema per la costruzione delle medie significative, senza passare da livelli di elaborazione intermedi;
ii. l’esecuzione di tutte le pre-elaborazioni, le elaborazioni e le normalizzazioni partendo dai dati istantanei;
iii. l’uniformità di dati e informazioni a corredo;
iv. l’esplicitazione nel MG delle fasi di acquisizione, di validazione, di pre-elaborazione, di elaborazione e normalizzazione dei dati.
2 Viene, ad esempio, modificata la definizione di “Normale Funzionamento” dell’impianto, il concetto di “Fondo Scala Strumentale” e di “Range di Validità” ed introdotta la definizione di “Sistema di Acquisizione Dati” (SAD).
3 Ora come “dato elementare” o “misura istantanea” deve intendersi: una misura costituita da singole letture o da dati ottenuti come media delle letture in un periodo non superiore al minuto. Modifica che, probabilmente, potrà essere oggetto di interpretazioni tra loro discordanti.
4 Non viene infatti più richiamata la UNI 10169:1993, ma la UNI 10169:2001, “Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot”, peraltro sostituita a maggio 2013 (quindi successivamente alla redazione dell’aggiornamento delle Linee Guida, ancorché precedentemente alla loro pubblicazione) dalla UNI EN ISO 16911-1:2013 “Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti – Parte 1: Metodo di riferimento manuale” e dalla UNI EN ISO 16911-2:2013 “Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti – Parte 2: Sistemi di misurazione automatici”. Le nuove norme di riferimento introducono importanti modifiche, separando l’ambito della misura eseguita e gestita da un ente terzo (Metodo di Riferimento Standard – SRM) da quella eseguita dal gestore tramite un sistema automatico (Sistema Automatico di Misurazione – AMS) ed introducendo modalità di correlazione con metodi manuali dei dati dell’AMS rispetto a quelli ottenuti con l’SRM, così come regolamentato dalla UNI EN 14181:2005.
5 Al fine di disciplinare una modalità di verifica del mantenimento della taratura degli strumenti migliorativa a carico del gestore, è stata individuata una procedura di verifica dei dati elementari su base settimanale. E’ stato quindi introdotto il concetto di “campo di misura complessivo” che non risulta definito nella LG e, vista la modalità della verifica, possa essere interpretato dal gestore o coincidente con il range di validità delle rette di taratura QAL2 ai sensi della UNI EN 14181 o coincidente con il massimo fondo scala disponibile. Questo passaggio necessiterebbe di un chiarimento per non introdurre ulteriori adempimenti a scapito dei gestori.
6 La definizione degli intervalli di confidenza e degli ELV (Valore Limite di Emissione) per i parametri O2, H2O, CO2 e NH3 consente ora ai gestori di poter valutare la possibilità di messa in gestione dei suddetti parametri ai sensi della UNI EN 14181:2005.
7 Sostanzialmente l’aggiornamento ha previsto:
• una maggiore semplificazione nel concetto di valutazione completa del sistema SME e Misure Ausiliarie;
• l’introduzione di un obbligo di gestione e verifica delle statistiche settimanali della UNI EN 14181:2005;
• lo snellimento degli obblighi di descrizione delle attività di manutenzione;
• la revisione della modalità di condivisione della procedura da mettere in atto in caso di guasto o fuori servizio del sistema SME;
• la specificazione del riferimento nell’Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per quanto attiene le attività di verifica e gestione delle normali derive strumentali per i sistemi SME non sottoposti a UNI EN 14181:2005;
• l’indicazione nella gestione dei dati risultanti dall’effettuazione della verifica dell’Indice di Accuratezza Relativo (IAR), che dovrebbe, quantomeno nella normalità dei casi, essere superiore a 10 mg/Nm3 (“ si può concludere che, qualora la verifica dello IAR sia svolta con concentrazioni inferiori a 10 mg/Nm3, le conclusioni di detta metodologia potrebbero non essere esaustive al fine di rispettare il mandato della normativa, ovvero la verifica che il sistema SME sia correttamente funzionante ed è necessario svolgere ulteriori indagini.”);
• l’utilizzo esclusivo della procedura prevista nella UNI EN 15259:2008 per la verifica della conformità della sezione di prelievo.
8 All’Allegato 1 del protocollo il Protocollo prevede sia paragrafi generali che schede tecniche specifiche. Nel dettaglio vengono definiti:
• i requisiti tecnici della strumentazione e dell’installazione
• i tempi e modi di implementazione della UNI EN 14181:2005;
• i tempi per l’effettuazione delle attività di QAL2 (Quality Assurance Level 2) e di QAL3 previsti dalla norma
• i tempi per l’adeguamento del SAD alla norma e a quanto riportato nella Guida Tecnica ISPRA Rev. 6 del 4 ottobre 2012, fissando, quale termine ultimo, il 31.12.2014 (comunque non oltre il 31.12.2013 i gestori dovranno far implementare funzioni che rendano disponibili i dati elementari);
• i criteri complessivi per impostare i fondi scala della strumentazione analitica per garantire la qualità del dato
• gli aspetti di dettaglio per la gestione del flusso dei dati elementari acquisiti e delle pre elaborazioni da prevedere nel SAD;
• la gestione dei transitori per gli impianti d’incenerimento;
• i codici di validità da associare ai dati gestiti dal SAD: dati elementari, dati semiorari emissioni, dati semiorari impianto, dati giornalieri;
• l’archiviazione e storicizzazione dei dati con il dettaglio dei formati disponibili per la consultazione dell’Ente di Controllo;
• le forme alternative di controllo che possono essere messe in atto dal Gestore in caso di mancata comunicazione tra strumentazione e SAD.
9 La nuova direttiva, cd. “IED”, in tema di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ha lo scopo di proseguire nel processo di riduzione delle emissioni delle installazioni industriali.



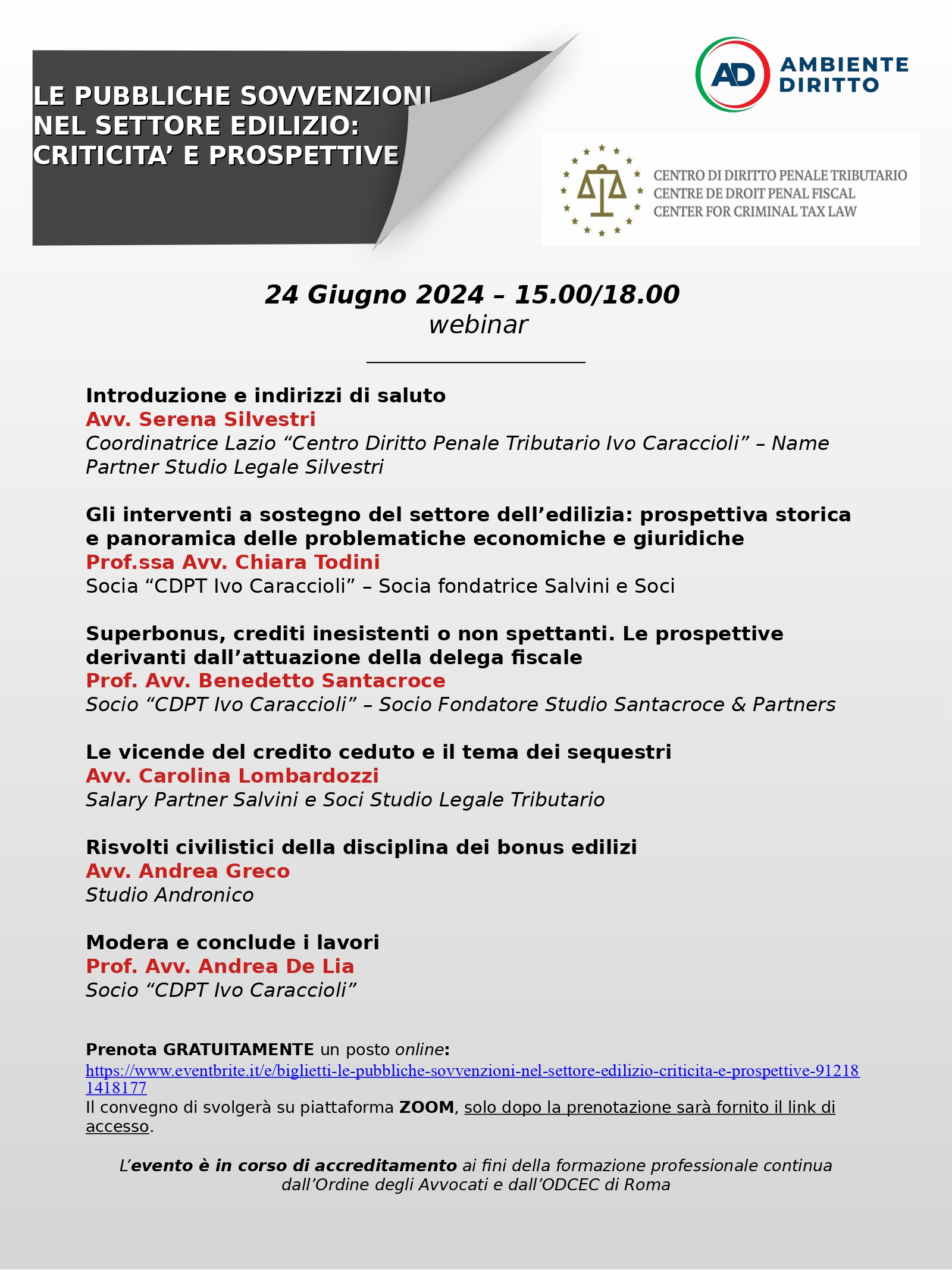

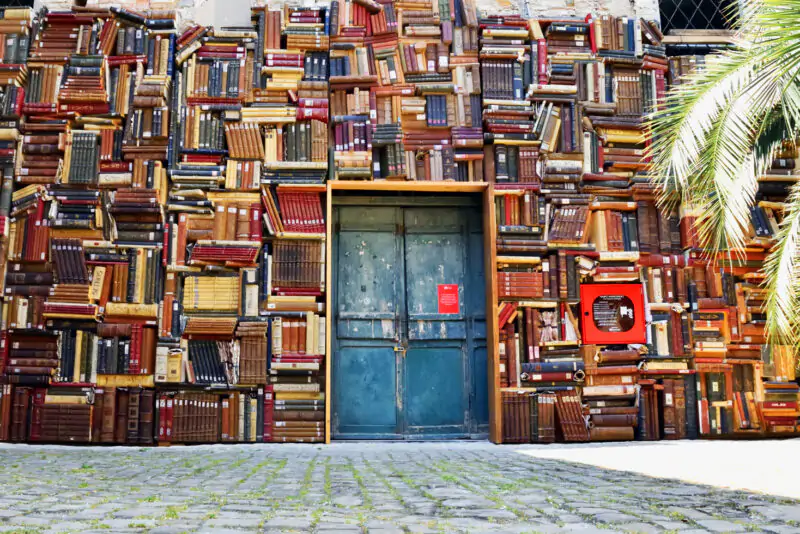 AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE
AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE