La direttiva 2012/27 UE: un concreto passo in avanti verso il miglioramento della resa energetica in Europa.
MAURO PETRACCA
1. Il quadro di riferimento. 2. Il contenuto della direttiva 2012/27 UE. 3. Conclusioni.
1. Il quadro di riferimento.
Nel corso degli anni, anche grazie alla programmazione del c.d. Piano 20-20-20 dell’Unione,1 un ruolo decisamente rilevante è stato attribuito alla politica in materia di contenimento della domanda energetica.
La Commissione Europea si è fatta portavoce di numerose istanze in tale ambito, favorendo diversi impulsi legislativi volti al miglioramento del risparmio energetico in Europa.
Tra i provvedimenti si possono annoverare, ad esempio, la direttiva 2004/8 CE in materia di cogenerazione2, la direttiva 2006/32 CE sull’efficienza degli usi finali dell’energia3, la direttiva 2010/31 UE sulla prestazione energetica nell’edilizia4
Parallelamente alla normativa specifica di settore, si è assistito alla emanazione di diversi documenti programmatici, il cui intento era quello di orientare l’operato dei singoli Stati membri verso un migliore utilizzo delle risorse.5
Orbene, per quanto la legislazione comunitaria fosse stata concepita in modo da migliorare considerevolmente il rendimento energetico nei principali settori di consumo, questa da sola non avrebbe consentito di realizzare risparmi sufficienti per conseguire l’obiettivo della riduzione del 20% dei consumi entro il 20206.
I maggiori ostacoli al miglioramento dell’efficienza energetica venivano individuati nella carente attuazione della legislazione vigente da parte dei singoli Stati, nella mancata consapevolezza dei consumatori e nell’assenza di strutture adeguate che incentivassero investimenti fondamentali.
Era necessario, pertanto, un nuovo intervento.
Bisognava aggiornare il quadro giuridico dell’Unione con un provvedimento che perseguisse concretamente l’obiettivo generale della riduzione del 20% del consumo di energia primaria entro il 2020 e la realizzazione di ulteriori miglioramenti dopo il 2020.
2. Il contenuto della direttiva 2012/27/UE.
Così, dopo diverse proposte senza seguito, il 25 ottobre 2012 è stata emanata la direttiva 2012/27 UE sull’efficienza energetica7.
In tal modo si conclude l’iter legislativo di approvazione della Energy Efficiency Directive, iniziato dalla Commissione Europea, nel giugno del 2011, con una proposta contenente misure giuridicamente vincolanti atte a prescrivere un maggior impegno degli Stati membri nell’utilizzare l’energia in maniera più efficiente in tutti gli stadi della catena energetica: dalla sua trasformazione fino alla sua distribuzione ed al suo consumo finale; iter proseguito successivamente con il voto favorevole (632 voti favorevoli contro 25 contrari) del Parlamento Europeo l’11 settembre 2012 e conclusosi con la ratifica del testo finale da parte del Consiglio Europeo lo scorso 04 ottobre8.
La direttiva è entrata in vigore il 04 dicembre 2012 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 05 giugno 20149.
Tale provvedimento stabilisce un quadro comune per promuovere l’efficienza energetica all’interno dell’Unione, definisce interventi specifici per attuare alcune delle proposte incluse nel “Piano efficienza energetica 2011”10 e concretizza le notevoli potenzialità di risparmio energetico da esso individuate e non realizzate.
Viene previsto che ciascuno Stato membro individui un obiettivo nazionale indicativo di efficienza, basato sul consumo e sul risparmio di energia primaria o finale o sull’intensità energetica.
I suddetti obiettivi dovranno essere notificati alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 2013, precisando come, e in base a quali dati, siano stati effettuati i calcoli.
Nel definire gli obiettivi, gli Stati devono tenere conto, tra l’altro, del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell’Unione non dovrà essere superiore a 1.474 Mtep di energia primaria e non superiore a 1.070 Mtep di energia finale.
Entro il 30 giugno 2014 la Commissione, sulla base dei dati forniti dai singoli Stati, dovrà valutare se l’Unione sarà in grado di far rientrare i propri consumi all’interno dei limiti di cui sopra.11
La direttiva, poi, attribuisce un ruolo strategico al rendimento energetico degli edifici.
In particolare, viene previsto che gli Stati membri elaborino, entro il 30 aprile 2014 e successivamente ogni tre anni, nel quadro dei Piani Nazionali d’Azione sull’Efficienza Energetica (PNAEE), una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.
Con specifico riferimento agli edifici pubblici, viene imposto agli Stati di garantire che, dal 1° gennaio 2014, almeno il 3% degli edifici pubblici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 – soglia che verrà abbassata a 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015 – sia ristrutturato ogni anno per rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla direttiva 2010/31 UE.
Agli Stati viene data la possibilità di stabilire se escludere dall’applicazione di tali requisiti tipologie di edifici particolari, come ad esempio quelli ad elevato interesse storico o religioso, ovvero edifici di proprietà delle forze armate.
Inoltre, nell’ipotesi di ristrutturazione di edifici pubblici per una percentuale maggiore del 3%, è data la possibilità di contabilizzare l’eccesso nel tasso di ristrutturazione di uno dei tre anni precedenti o seguenti.
Ed ancora, viene raccomandato di provvedere affinché si investa esclusivamente su prodotti, servizi o edifici ad alta efficienza (valutando il rapporto costi-efficacia) e ciò sia a livello centrale che regionale o locale.12
Tali investimenti andranno eseguiti nell’ambito di un regime nazionale obbligatorio di efficienza istituito dai singoli Stati, i quali dovranno stabilire un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020.
Detto obiettivo dovrà essere almeno equivalente al conseguimento, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di risparmi annuali pari all’1,5 % delle vendite medie annue di energia ai clienti finali da parte di tutti i distributori o società di vendita al dettaglio, realizzate nell’ultimo triennio precedente al 1° gennaio 2013.
La direttiva, peraltro, prevede delle deroghe rispetto ai modi con cui effettuare il calcolo del risparmio annuale, lasciando un discreto margine di manovra agli Stati in relazione alle tipologie di attività energetiche da poter inserire (es. risparmi realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia); purché tali scelte e le eventuali diverse modalità di calcolo, vengano notificati alla Commissione entro il 05 giugno 2014.
Inoltre, in alternativa al previsto regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica, gli Stati membri possono scegliere di adottare altre misure politiche per realizzare risparmi tra i clienti finali, a condizione che tali misure prevedano, tra l’altro, almeno due fasi temporali (“periodi”) intermedie entro il 31 dicembre 2020; che venga redatta e resa pubblica dalle parti partecipanti una relazione annuale sui risparmi conseguiti; che venga assicurato il monitoraggio dei risultati ed istituito un sistema di controllo sulle misure di miglioramento poste in essere.
Tra le suddette misure possono essere incluse in via non esaustiva: a) le imposte sull’energia o sul CO2 che hanno l’effetto di ridurre il consumo finale di energia; b) regimi o strumenti di finanziamento o incentivi fiscali che portano all’applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico; c) standard e norme dirette a migliorare l’efficienza energetica dei prodotti e dei servizi, compresi gli edifici ed i veicoli; d) regimi di etichettatura energetica.13
Come già previsto nel “Piano efficienza energetica 2011” di cui supra, anche il provvedimento di cui ci si occupa richiede agli Stati una collaborazione in ordine all’istituzione di sistemi di audit energetico.
I detti sistemi saranno obbligatori per le grandi imprese, le quali dovranno sottoporvisi entro il 05 dicembre 2015 e poi ogni quattro anni.14
Per le piccole e medie imprese (PMI), invece, non sussiste alcun obbligo, ma dovranno essere gli Stati membri ad elaborare programmi tesi ad incoraggiarne l’utilizzo.
In ogni caso, i sistemi di audit dovranno essere gestiti in maniera autonoma da esperti qualificati ed eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.15
In merito alla misurazione dei consumi effettuati, la direttiva impone agli Stati, ove sia tecnicamente ed economicamente possibile, di provvedere affinché i clienti finali possano disporre, a prezzi concorrenziali, di “contatori intelligenti” che garantiscano corrette informazioni sul consumo.
Tale contatore deve essere sempre fornito quando: a) si sostituisca un contatore esistente, salvo che ciò sia tecnicamente impossibile o non efficiente in termini di costi in relazione al potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine; b) si proceda ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguano importanti ristrutturazioni.
Indipendentemente dall’installazione dei suddetti contatori, gli Stati devono garantire che le informazioni sulla fatturazione siano chiare, precise e fondate sul consumo reale.
Inoltre, bisogna garantire che i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e informazioni sulla fatturazione per il consumo di energia e che possano accedere in modo appropriato e gratuitamente ai dati relativi ai loro consumi.
Relativamente alle statuizioni di cui sopra, viene espressamente attribuito agli Stati l’obbligo di stabilire le sanzioni in caso di inosservanza delle norme nazionali di attuazione.
Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive e le disposizioni che le prevedono dovranno essere notificate alla Commissione entro il 05 giugno 2014.16
Per quanto riguarda la promozione dei sistemi di cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento, la direttiva impone agli Stati membri di valutarne l’applicabilità sui propri territori e notificare i risultati alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.
Nel compiere la valutazione, si dovrà tenere conto del rapporto tra costi e benefici, basato sulle condizioni climatiche, sulla fattibilità economica e sull’idoneità tecnica dei siti.
Qualora la valutazione abbia esito positivo ed i vantaggi siano superiori ai costi, gli Stati membri dovranno adottare misure adeguate affinché siano sviluppate infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, nonché di cogenerazione ad alto rendimento.
Viceversa, qualora gli esiti delle varie analisi siano negative, le installazioni potranno essere esentate da tali adeguamenti.17
In merito alla trasformazione, trasmissione e distribuzione di energia, il provvedimento richiede uno sforzo agli Stati per garantire la sicurezza e l’efficienza delle reti.
In particolare, gli Stati membri dovranno garantire che le autorità nazionali di regolamentazione, attraverso lo sviluppo delle tariffe di rete ed attraverso la regolamentazione delle reti stesse, incoraggino gli operatori a mettere a disposizione degli utenti servizi che consentano loro di attuare misure di miglioramento dell’efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti.
Inoltre, dovrà essere assicurata la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l’efficienza generale (ivi compresa l’efficienza energetica) della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica o che possano ostacolare la partecipazione alla gestione della domanda, nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari.
Tutto ciò, cercando di garantire l’accesso o il dispacciamento prioritario per la cogenerazione ad alto rendimento.18
Gli Stati dovranno provvedere affinché le informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e ai quadri finanziari e giuridici siano trasparenti e divulgate a tutti i pertinenti attori del mercato (tra gli altri, consumatori, costruttori, architetti, ingegneri) promuovendo adeguate iniziative di sensibilizzazione e formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici legati all’adozione di misure di miglioramento dell’efficienza energetica.
La direttiva, poi, suggerisce diversi interventi agli Stati per promuovere il mercato dei servizi energetici e l’accesso delle PMI a tale mercato: ad esempio, diffondere informazioni chiare e accessibili sui contratti relativi ai servizi energetici disponibili ovvero rendere pubblici e aggiornare periodicamente un elenco dei fornitori di servizi energetici qualificati e/o certificati.
Inoltre, vengono individuate ulteriori misure per rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all’efficienza energetica: una di queste interviene sul problema della c.d. “frammentazione degli incentivi”19, già individuato dal Piano del 2011, stabilendo che, in materia di proprietà e locazione, è necessario separare gli incentivi tra proprietari e inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari; in tal modo, si vuole evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare il rendimento energetico, perché non ne otterrebbero individualmente i pieni vantaggi o perché manchino regole che disciplinino la ripartizione dei costi e dei benefici.
In generale, comunque, le misure destinate a eliminare gli ostacoli possono comprendere l’erogazione d’incentivi, l’abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, l’adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle procedure amministrative.
Tali misure dovranno successivamente essere notificate alla Commissione con i piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica.20
In merito alle agevolazioni finanziarie, la direttiva prevede che, fermo restando la disciplina prevista dagli artt. 107 e 108 TFUE21, gli Stati membri potranno favorire l’istituzione di strumenti finanziari nuovi o eventualmente il ricorso a quelli esistenti, così da ottenere molteplici canali di finanziamento e una massimizzazione dei vantaggi.
In tale ambito la Commissione, ove lo riterrà opportuno, potrà assistere gli Stati nella messa a punto dei vari meccanismi finanziari e dei regimi di supporto tecnico per incrementare il rendimento energetico in vari settori.
Inoltre, gli Stati potranno istituire un fondo destinato a sostenere iniziative nazionali in materia di efficienza energetica, all’interno del quale confluiranno anche i contributi corrispondenti agli investimenti richiesti per adempiere i vari obblighi.22
Infine, la direttiva stabilisce che entro il 30 aprile 2014 e successivamente ogni tre anni, gli Stati dovranno presentare i propri piani d’azione nazionali contenenti le misure significative di miglioramento dell’efficienza ed i risparmi di energia attesi e/o conseguiti.
Spetterà poi alla Commissione esaminare le relazioni annuali ed i vari piani, valutando se e in che misura siano stati realizzati progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali. A secondo degli esiti di tale valutazione la Commissione potrà formulare raccomandazioni ai singoli Stati.23
3. Conclusioni
Alla luce dell’analisi realizzata, è possibile affermare che con la direttiva 2012/27 UE vengono compiuti notevoli passi in avanti, non solo nei contenuti, sicuramente più conformi alle impellenti incombenze da dover affrontare a livello mondiale, ma anche nell’ottica di una maggiore cogenza delle disposizioni e di una minore autonomia degli Stati nell’effettuare le singole valutazioni.
Con tale provvedimento, in sostanza, si è cercato di uniformare le scelte Europee verso un futuro volto ad un concreto risparmio energetico e ad una notevole riduzione delle emissioni inquinanti.
Condividendo il pensiero di Federico Grazioli, presidente dell’ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento): “La nuova direttiva europea sull’efficienza rappresenta un ottimo passo avanti nella direzione delle politiche di risparmio ed efficienza energetica dei paesi e delle aziende coinvolte”.
1 Il Consiglio Europeo del marzo 2007, facendo proprio quanto già affermato dalla Commissione nella Comunicazione del 10 gennaio 2007 “Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius – La via da percorrere fino al 2020 e oltre”, ha programmato il c.d. Piano 20-20-20 dell’Unione, individuando la necessità, entro il 2020, di ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, di aumentare al 20% il consumo delle FER e di portare al 20% il risparmio energetico.
2 Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE in G.U. L 52/50 del 21 febbraio 2004.
3 Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio in G.U. L 114/64 del 27.4.2006.
4 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia in G.U. L153/13 del 18 giugno 2010.
5 Ci si riferisce in particolare ai tre Piani sull’Efficienza Energetica dell’Unione del 2000, 2006 e 2011.
6 Cfr. dossier A. Checchi, La politica energetica dell’Unione Europea, gennaio 2009, n 109.
7 Direttiva 2012/27 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE in G.U. L 315/1 del 14 novembre 2012.
8 G. Grazioli, Efficienza energetica: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Direttiva 2012/27/UE in riv. elet. di dir. pub. Amministrazioni in cammino – un laboratorio formativo e sperimentale in amministrazioneincammino.luiss.it.
9 Il 05 giugno 2014 è anche la data in cui verranno abrogate le direttive 2006/32 CE (usi finali dell’energia) e 2004/8 CE (cogenerazione).
10 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “ Piano di efficienza energetica 2011”, Bruxelles, 8 marzo 2011, COM (2011) 109 def
11 Cfr. art. 3.
12 Cfr. artt. 4- 6.
13 Cfr. art. 7.
14 Sul punto F. Petrucci, Direttiva efficienza, per le grandi imprese audit energetico obbligatorio in reteambiente.it.
15 Cfr. art. 8.
16 Cfr. artt. 9-13.
17 Cfr. art. 14.
18 Cfr. art. 15.
19 Questa locuzione descrive la situazione comune in cui sia i proprietari che gli affittuari sono riluttanti a pagare per migliorare la prestazione energetica di un immobile in locazione in quanto i benefici sono condivisi fra le due parti.
20 Cfr. artt. 17-19.
21 Gli artt. 107, 108 e 109 TFUE individuano la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato, introducendo alcune modifiche rispetto a quanto già disposto dai previgenti artt. 87, 88 e 89 TCE
22 Cfr. art. 20.
23 Cfr. art 24.



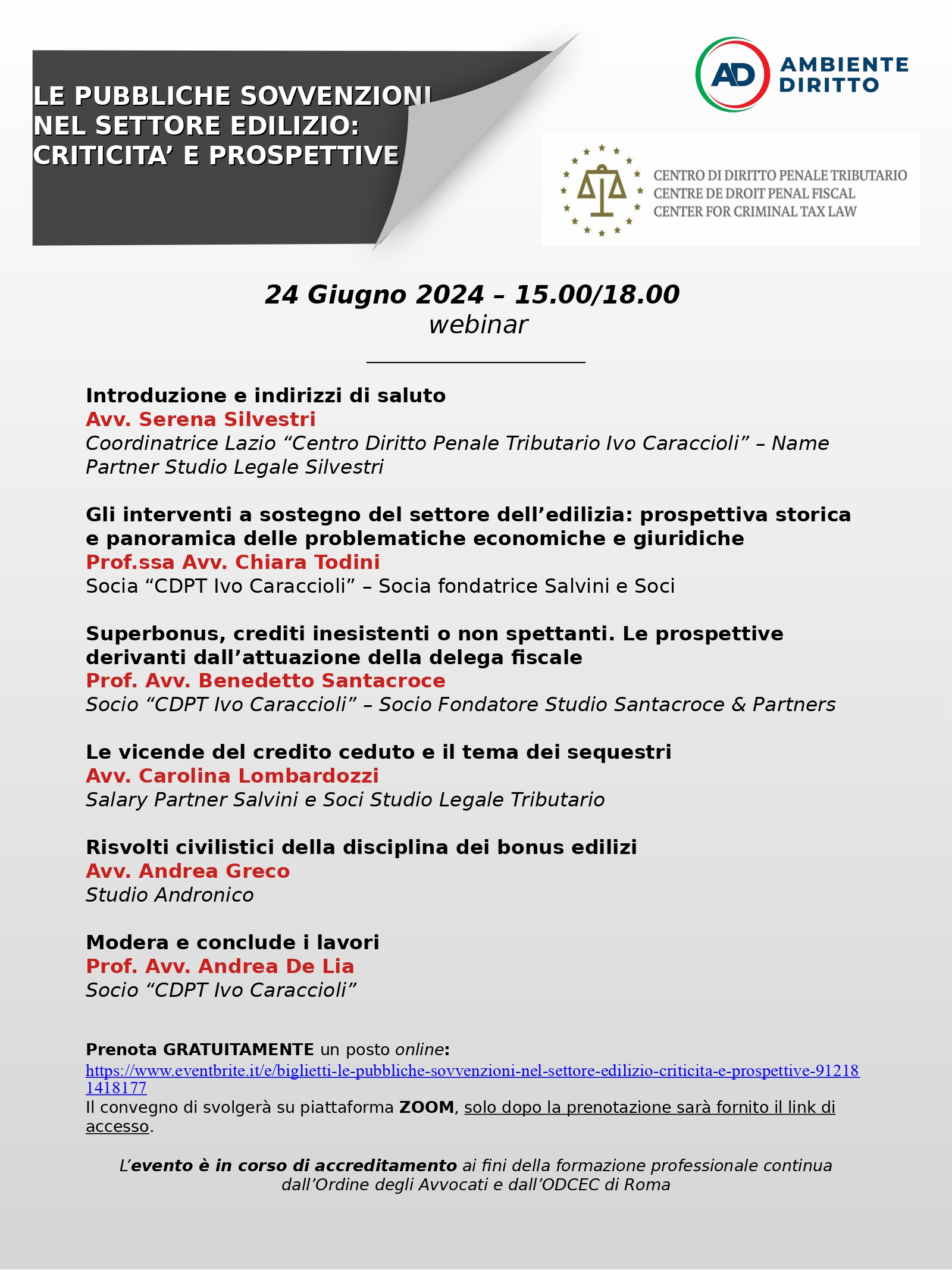

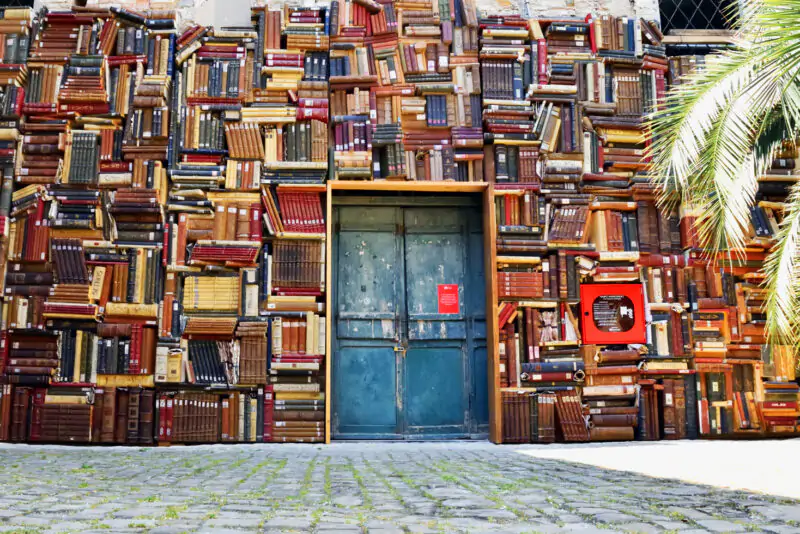 AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE
AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE