L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE TRA SEMPLIFICAZIONI E COMPLICAZIONI
FABRIZIO LORENZOTTI*
1. La produzione normativa sull’autorizzazione unica ambientale. – L’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, successivamente ribattezzato come “Semplifica Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha demandato al Governo l’emanazione di un regolamento volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale, con la finalità di semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Il medesimo articolo ha enunciato tre criteri direttivi, cosicché la nuova autorizzazione:
a) deve sostituire ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione in materia ambientale;
b) è rilasciata da un unico ente;
c) costituisce l’atto conclusivo di un procedimento caratterizzato dal principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché dall’esigenza di tutela degli interessi pubblici, che non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
In attuazione dell’art. 23, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, contiene il regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale, in vigore dal 13 giugno 2013.
Nonostante le intenzioni di semplificazione e i tre criteri direttivi il regolamento, come sempre più spesso accade con la produzione normativa italiana, difetta in chiarezza ed è fonte di parecchie complicazioni, tanto è vero che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, abbastanza presto ha diramato la circolare 7 novembre 2013, n. 0049801, ammettendo che sono pervenute numerose richieste di chiarimenti riguardo all’interpretazione del DPR n. 59/2013.
Inoltre (e avremo modo di verificarlo nei paragrafi successivi), sussistono problemi sull’effettivo rispetto dei tre criteri direttivi e si può fin da ora anticipare che il primo di essi (quello della sostituzione delle molteplici autorizzazioni ambientali) è rimasto senza attuazione.
2. Il contesto in cui interviene l’autorizzazione unica ambientale e le preoccupazioni della Commissione europea. – La nuova disciplina è stata approntata con la finalità di far fronte ad una situazione abbastanza complicata, caratterizzata dalla presenza di parecchie tipologie di autorizzazioni ambientali, di competenza di enti e organi diversi, previste da molteplici normative e di cui le imprese devono munirsi, con un carico crescente di adempimenti burocratici e di costi di gestione.
Ad avviso delle piccole e medie imprese, la necessità di conformarsi ai regolamenti amministrativi costituisce un onere sempre più gravoso. L’appesantimento risulta anche dalla comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, in data 30 settembre 2008, ed intitolata: Pensare anzitutto in piccolo (“Think Small First”). Uno “Small Business Act” per l’Europa.
Afferma la comunicazione: “Secondo le PMI (piccole medie imprese), conformarsi ai regolamenti amministrativi costituisce l’onere più pesante. Le PMI sostengono in effetti oneri amministrativi e normativi sproporzionati rispetto alle imprese più grandi. Secondo talune stime, se una grande impresa spende un euro per dipendente per soddisfare obblighi di legge, una PMI può giungere a spendere in media fino a dieci euro. Il 36% delle PMI europee sostiene che negli ultimi 2 anni le formalità burocratiche hanno nuociuto all’attività economica”.
A quanto constatato dalla comunicazione, è necessario aggiungere che si tratta di un onere non soltanto monetario ma che pesa anche sotto il profilo dei tempi di attesa, vista la molteplicità delle autorizzazioni e dei conseguenti tempi burocratici di svolgimento dei procedimenti.
Il 23 febbraio 2011, la Commissione europea ha varato un documento contenente: Riesame dello “Small Business Act” per l’Europa, secondo cui: “L’attuazione del principio “Think small first” resta al centro dello SBA (Small Business Act). Essa implica una semplificazione del contesto normativo e amministrativo in cui operano le PMI, in particolare per mezzo di norme ispirate a tale principio e a quello “una sola volta” o di strumenti come l’e-government e soluzioni del tipo sportello unico. La Commissione e gli Stati membri si sono sforzati di dare attuazione a questo principio, ma c’è ancora spazio per un’applicazione più sistematica sulla base dell’agenda dell’Unione europea per una regolamentazione intelligente”.
Dai contenuti delle suddette comunicazioni della Commissione europea discende con tutta evidenza quello che abbiamo sopra indicato come terzo criterio direttivo posto dall’art. 23 del decreto-legge n. 5/2012 in relazione all’autorizzazione unica ambientale, vale a dire l’introduzione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni delle imprese e ai loro settori di attività.
Tuttavia, proprio perché si tratta di un provvedimento destinato ad operare in materia ambientale, la nuova autorizzazione deve necessariamente rispettare, accanto ai principi di proporzionalità degli adempimenti amministrativi e di semplificazione, le esigenze di tutela della salute e dell’ecosistema. L’intreccio delle diverse esigenze è all’origine di alcuni dei passaggi procedimentali più complicati contenuti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 59/2013.
3. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento. – Sullo schema di regolamento, poi emanato con il D.P.R. n. 59/2013, il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha espresso parere favorevole (parere n. 5069/12 del 29 novembre 2012), osservando che il testo sottoposto al suo esame appare coerente con le finalità dell’intervento normativo primario; e che risulta altresì adeguata, sotto il profilo tecnico-giuridico, la normativa proposta.
Ha confermato l’attuazione del secondo criterio direttivo (previsto dall’art. 23 del decreto legge n. 5/2012) della riferibilità della competenza al rilascio dell’autorizzazione unica ad un solo ente ed il rispetto del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al suo settore di attività nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti (principi anche essi dettati dal citato art. 23).
Inoltre, accanto ad alcune osservazioni di carattere formale sulla formulazione dello schema di regolamento, il Consiglio di Stato ha criticato la durata eccessivamente lunga dell’autorizzazione unica, pari a quindici anni, decorrenti dalla data del suo rilascio, in assenza di modalità di “autocontrollo” previamente e specificamente definite in via generale.
Il rilievo non è stato accolto dal D.P.R. n. 59/2013 che ha mantenuto la lunga durata della nuova autorizzazione.
4. Le imprese che devono richiedere l’autorizzazione unica ambientale. – L’art. 1 del D.P.R. n. 59/2013, in primo luogo, precisa che, per individuare le imprese tenute a richiedere la nuova autorizzazione, è necessario fare riferimento all’art. 2 del D.M. Attività produttive 18 aprile 2005. Ciò comporta l’assoggettamento alla nuova disciplina delle imprese rientranti nella categoria delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese (categoria complessivamente definita “PMI”), costituita dalle imprese che, congiuntamente, soddisfano due requisiti: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Il fondamento normativo dell’art. 2 del decreto ministeriale va rinvenuto nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in base al quale la definizione di piccola e media impresa viene indicata e aggiornata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministro dello Sviluppo economico), in conformità con le disposizioni dell’Unione europea.
In secondo luogo, sempre l’art. 1 del D.P.R. n. 59/2013 dispone che è necessaria l’autorizzazione unica ambientale per i gestori degli impianti che non sono soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
In sintesi, l’autorizzazione unica ambientale interessa due categorie di imprese: le PMI e le grandi imprese che gestiscono impianti per i quali non è richiesta l’autorizzazione integrata ambientale.
La necessità di sapere quali siano questi ultimi impianti non viene però soddisfatta direttamente dal citato art. 1, ma bisogna effettuare autonomamente una ricerca e trovare l’art. 6, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), ai sensi del quale: l’autorizzazione integrata ambientale è necessaria per le installazioni che svolgono le attività di cui all’allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto n. 152/2006.
L’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 59/2013 aggiunge che l’autorizzazione unica ambientale non può essere richiesta per i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), allorquando la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006.
5. In quale momento richiedere l’autorizzazione unica ambientale e i sette titoli abilitativi di riferimento. – L’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 indica in quali occasioni i soggetti obbligati devono effettivamente chiedere l’autorizzazione unica ambientale. La richiesta va fatta quando essi siano assoggettati dalle normative vigenti al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento (ad esempio in caso di modifiche sostanziali agli impianti ai sensi dell’art. 6, comma 2, del medesimo D.P.R.) di almeno uno tra sette titoli abilitativi che vengono analiticamente indicati, purtroppo, in maniera abbastanza disordinata.
Per maggiore chiarezza si possono suddividere i titoli abilitativi in questione in due categorie, una prima categoria comprende quattro autorizzazioni:
1) l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui agli artt. 124 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006;
2) l’autorizzazione di cui all’art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;
3) l’autorizzazione generale per categorie di stabilimenti prevista dall’art. 272 del decreto legislativo n. 152/2006;
4) l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.
La seconda categoria comprende tre comunicazioni:
1) la comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende dedite alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura, o all’allevamento di bestiame, o che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola;
2) le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 (auto smaltimento) e 216 (operazioni di recupero) del decreto legislativo n. 152/2006;
3) la comunicazione o il nulla osta in tema di impatto acustico di cui all’art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
I titoli abilitativi di riferimento potranno diventare più di sette, poiché il comma 2 dell’art. 3 in esame aggiunge che, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente, le Regioni possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da ricomprendere nell’autorizzazione unica ambientale.
Si tratta chiaramente di una pessima soluzione, perché espone le imprese alla variabilità e molteplicità delle situazioni regionali, con alternanti aumenti dei costi istruttori e scoraggianti effetti sulla programmazione e gestione delle proprie attività.
Tra l’altro, la soluzione manda subito in soffitta la previsione (cfr. art. 10, comma 3, del regolamento) di un modello semplificato e unificato per la richiesta dell’autorizzazione unica ambientale.
Considerati gli attuali sette titoli abilitativi di riferimento, poteva sorgere il problema della scarsa utilità, anzi dell’aggravamento procedimentale, di dover chiedere l’autorizzazione unica ambientale quando un’impresa avrebbe potuto provvedere soltanto ad una o più delle tre comunicazioni sopra indicate o quando sarebbe bastata la (ugualmente sopra indicata) autorizzazione generale per categorie di stabilimenti di cui all’art. 272 del decreto legislativo n. 152/2006.
Opportunamente, il comma 3 dell’art. 3 in esame rimette ai gestori degli impianti la facoltà di non richiedere, in casi del genere, l’autorizzazione unica, limitandosi a presentare la comunicazione o l’istanza tramite lo Sportello unica delle attività produttive (d’ora in poi SUAP) del Comune o dei Comuni associati del luogo dove sorge l’impianto da autorizzare.
Anche la citata circolare ministeriale del 7 novembre 2013 precisa che l’obbligo di richiedere l’autorizzazione unica ambientale conosce due eccezioni, consistenti nella opportunità per il gestore: 1) di non avvalersi dell’autorizzazione qualora l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (art. 3, comma 3, del regolamento n. 59/2013); 2) di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (art. 7, comma l, del medesimo regolamento).
Ovviamente, la circolare aggiunge che la suddetta opportunità va estesa alle ipotesi di attività soggette unicamente a più comunicazioni oppure alle autorizzazioni di carattere generale.
A parte le due riferite eccezioni, in tutti gli altri casi i titoli abilitativi devono essere necessariamente sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale.
In tal senso si esprime anche la circolare ministeriale che dedica il suo paragrafo 2 alla natura obbligatoria o facoltativa dell’AUA (autorizzazione unica ambientale) e osserva, correttamente che il verbo servile (può) utilizzato dall’art.10, comma 2, del D.P.R. n. 59/2013 (secondo cui “l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito”), lungi dal prescrivere la facoltatività dei passaggi procedimentali in cui si articola il nuovo provvedimento autorizzatorio unico, sta piuttosto ad indicare il discrimine temporale a partire dal quale deve ritenersi vigente il nuovo regime. Pertanto, l’art. 10, comma 2, si interpreta nel senso che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, comma 1, del regolamento salvo che ricorra una delle due citate deroghe.
Come accennato all’inizio del presente paragrafo, l’autorizzazione unica deve essere richiesta dall’impresa interessata prima dell’inizio di una nuova attività (ovviamente sottoposta ad uno dei sette titoli abilitativi di riferimento, sempre che singole Regioni non amplino questo numero e fermo restando quanto precisato in precedenza per le mere comunicazioni e per le autorizzazioni generali).
Per gli impianti già autorizzati in base alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 59/2013, l’autorizzazione unica deve essere richiesta prima della scadenza di uno dei sette titoli abilitativi di riferimento oppure in caso di modifica sostanziale dell’impianto (anche in questi casi valgono le precisazioni riportate tra parentesi qualche riga sopra).
Sulla questione è importante la circolare ministeriale del 7 novembre 2013, quando pone l’interrogativo se preferire il termine indicato dalle norme di settore ovvero generalizzare l’indicazione contenuta nel regolamento n. 59/2013 “alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito” (art. 10, comma 2). La circolare afferma che deve ritenersi preferibile l’interpretazione per cui l’art. 10, comma 2 sia “norma generale destinata ad essere derogata dalle norme settoriali che eventualmente prevedano termini diversi per la presentazione della domanda di titolo abilitativo; ciò non per un astratto ossequio al canone della specialità (che impone di risolvere in tal senso eventuali antinomie tra le fonti), ma piuttosto per l’evidente lacuna che la soluzione opposta verrebbe ad ingenerare. L’art. 10, infatti, lascerebbe aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza. Per contro, le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini. Appare pertanto utile, oltre che necessitato dall’analisi ermeneutica, rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’autorizzazione unica”.
6. Il procedimento per ottenere l’autorizzazione unica ambientale. – Le imprese individuate nel precedente paragrafo 4 hanno come esclusivo punto di riferimento, durante tutto il procedimento inteso ad ottenere la nuova autorizzazione, il SUAP.
In base all’art. 2, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva. Esso fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
Il successivo art. 4 specifica gli adempimenti procedimentali: il SUAP riceve la domanda, con gli atti allegati richiesti dalla normativa, trasmessa dalle imprese in forma telematica (pertanto, le pratiche presentate in forma cartacea non possono essere trattate) e la trasmette immediatamente, sempre in forma telematica, alla Provincia ed agli enti competenti in materia ambientale. La domanda deve indicare quali tra i sette atti di comunicazione e di autorizzazione verranno sostituiti dell’autorizzazione unica ambientale.
Inoltre il SUAP, in accordo con la Provincia o con la diversa autorità competente indicata dalle Regioni, provvede – entro trenta giorni dal ricevimento della domanda – ad una verifica della correttezza formale del materiale presentato. Decorsi i trenta giorni, in assenza di comunicazioni alle imprese presentatrici, la domanda si intende correttamente presentata.
Se sono necessarie delle integrazioni, il SUAP provvede a richiederle alle imprese, fissando il termine per la loro trasmissione. Decorso inutilmente il termine per le integrazioni, la domanda è archiviata.
L’art. 10, comma 3, del regolamento ha previsto l’adozione (con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata) di un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale.
Nell’attesa del modello statale, Regioni e Province hanno predisposto propri modelli. Evidentemente il ritardo di uscita del modello unificato statale costituisce un altro pessimo comportamento, perché espone le imprese alla variabilità e molteplicità dei modelli disponibili.
7. Il provvedimento conclusivo del procedimento e il soggetto competente. – In base all’art. 2, comma 1, lettera a), del regolamento, l’autorizzazione unica ambientale è il provvedimento rilasciato dal SUAP.
Però, la successiva lettera b) stabilisce che l’autorità competente per tale autorizzazione è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (d’ora in poi, invece di ripetere in continuazione: “la Provincia o la diversa autorità competente”, ci riferiamo soltanto alla Provincia sottintendendo il resto).
Le due disposizioni potrebbero condurre il veloce lettore su una falsa pista e cioè che il SUAP svolga soltanto una funzione di trasmissione, di passacarte, della decisione presa dalla Provincia.
Che i ruoli del SUAP e della Provincia non siano questi, viene precisato dal seguito della sopra citata lettera b), secondo cui l’autorizzazione provinciale confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’art. 14-ter, comma 6 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’evocazione dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, che contiene il regolamento sulla disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del SUAP, sta a significare che spetta proprio al SUAP l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento (cfr. il comma 2 dell’art. 7 del regolamento sul SUAP). In sostanza, il regolamento sul SUAP ha prefigurato per questo organo un procedimento unico e la titolarità del provvedimento conclusivo, che devono essere rispettati anche in tema di autorizzazione unica ambientale.
Ugualmente, l’evocazione dell’art. 14-ter, comma 6 bis, della legge n. 241/1990 sta a significare – nel caso in cui oltre all’autorizzazione unica, siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso – che, all’esito dei lavori della conferenza di servizi, valutate le specifiche risultanze della conferenza stessa e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, il SUAP deve adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza.
Almeno formalmente appare rispettato il secondo criterio direttivo formulato dall’art. 23 del decreto legge n. 5/2012 (e cioè che l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente). Però, il SUAP, pur rilasciando il provvedimento conclusivo in base alle considerazioni ora svolte – non può essere definito un ente. Forse, il legislatore, dettando il secondo criterio, non aveva in mente il SUAP, ma un vero e proprio ente. Su questo punto comunque si può concludere che il SUAP fa capo ad un Comune o ad un’associazione di Comuni e, pertanto, l’ente è sempre individuabile.
Inoltre, nel caso di diniego dell’autorizzazione, l’impresa dovrà proporre ricorso al T.A.R. avverso il provvedimento negativo del SUAP o della Provincia?
La risposta chiaramente, sempre in base alle considerazioni sopra formulate, è nel senso che il ricorso va proposto contro il provvedimento del SUAP e quindi del Comune o dell’associazione dei Comuni titolari dello sportello.
Però, sotto il profilo delle spese legali e delle responsabilità il Comune o i Comuni pagherebbero anche per decisioni negative spesso imputabili alla Provincia.
Di diverso avviso sono “Le linee guida applicative sul DPR 59/2013” pubblicate dalla Confindustria, rintracciabili su parecchi siti Internet, secondo cui: “La Provincia assume le funzioni di autorità competente, con responsabilità sui contenuti dell’autorizzazione”.
8. I termini per il rilascio dell’autorizzazione unica. – I termini sono fissati dall’art. 4, commi 4 e seguenti, del regolamento.
Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in misura inferiore o pari a 90 giorni, la Provincia adotta il provvedimento finale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia l’autorizzazione. In questi casi la convocazione della conferenza di servizi è facoltativa, in conformità a quanto stabilito dall’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010.
Se l’autorizzazione sostituisce titoli abilitativi, per almeno uno dei quali, la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP deve indire, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conferenza dei servizi di cui all’art. 7 da ultimo citato. La Provincia adotta l’autorizzazione entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, oppure – nei casi in cui siano state richieste integrazioni documentali – entro 150 giorni dal ricevimento della domanda.
Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti, l’art. 11 del regolamento prevede l’applicazione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 2, commi da 9 bis a 9 quinquies della legge n. 241/1990.
9. La durata e il rinnovo dell’autorizzazione unica. – L’autorizzazione unica ambientale ha una durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio (art. 3, comma 6, del regolamento). Essa definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dalla Provincia tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività. In presenza di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’art. 108 del decreto legislativo n. 152/2006, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo alla Provincia, che potrà procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario. L’aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione (art. 3, comma 5, del regolamento).
Le imprese (art. 5 del regolamento) devono chiedere, sempre tramite il SUAP, il rinnovo dell’autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza. Non è necessario allegare alla domanda di rinnovo una ulteriore documentazione se le condizioni d’esercizio, o le informazioni contenute nella documentazione presentata in passato, siano rimaste immutate.
Per il resto, il procedimento di rinnovo segue le stesse regole fissate per la presentazione della domanda di autorizzazione originaria.
La Provincia può comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza quando: a) le prescrizioni precedenti impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
b) lo esigono nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.
10. L’autorizzazione unica ambientale è veramente unica? – L’art. 23 del decreto-legge 5/2012 ha formulato chiaramente il primo criterio direttivo, disponendo che la nuova autorizzazione deve sostituire ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione in materia ambientale.
In realtà, continuano a sussistere diverse autorizzazioni che non sono state sostituite dalla nuova autorizzazione unica e che sono, a loro volta, caratterizzate dalla unicità del procedimento che conduce al loro rilascio.
Si possono citare quali esempi:
a) l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo n. 152/06;
b) il procedimento unico per gli interventi di bonifica dei siti contaminati di cui all’art. 242 del medesimo decreto legislativo;
c) il procedimento unico per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e all’art. 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Conclusioni. – L’esame della disciplina della nuova autorizzazione conferma quanto anticipato nel paragrafo 1: il regolamento n. 59/2013 difetta in chiarezza ed è fonte di parecchie complicazioni.
Una pessima soluzione è stata quella di consentire che le Regioni possano ampliare i titoli abilitativi da sostituire con l’autorizzazione unica ambientale, esponendo le imprese alla variabilità e molteplicità delle situazioni regionali e vanificando la promessa di un modello semplificato e unificato, formulato in sede statale, per la richiesta dell’autorizzazione.
Abbastanza confusa è risultata l’attuazione del secondo criterio direttivo formulato dall’art. 23 del decreto legge n. 5/2012 (e cioè che l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente) perché si sovrappongono le funzioni del SUAP e della Provincia.
E’ stato disatteso il primo criterio direttivo di cui al medesimo art. 23, perché continuano ad esistere più autorizzazioni uniche di tipo ambientale.
* professore associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino
Pubblicato su AmbienteDiritto.it il 6 novembre 2014
AmbienteDiritto.it – Rivista Giuridica Telematica – Electronic Law Review – Via Filangeri, 19 – 98078 Tortorici ME – Tel +39 0941 421391 – Tel. +39 0941 430270 Fax digitale +39 1782724258 – Mob. +39 3383702058 – info@ambientediritto.it – Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 – ISSN 1974-9562



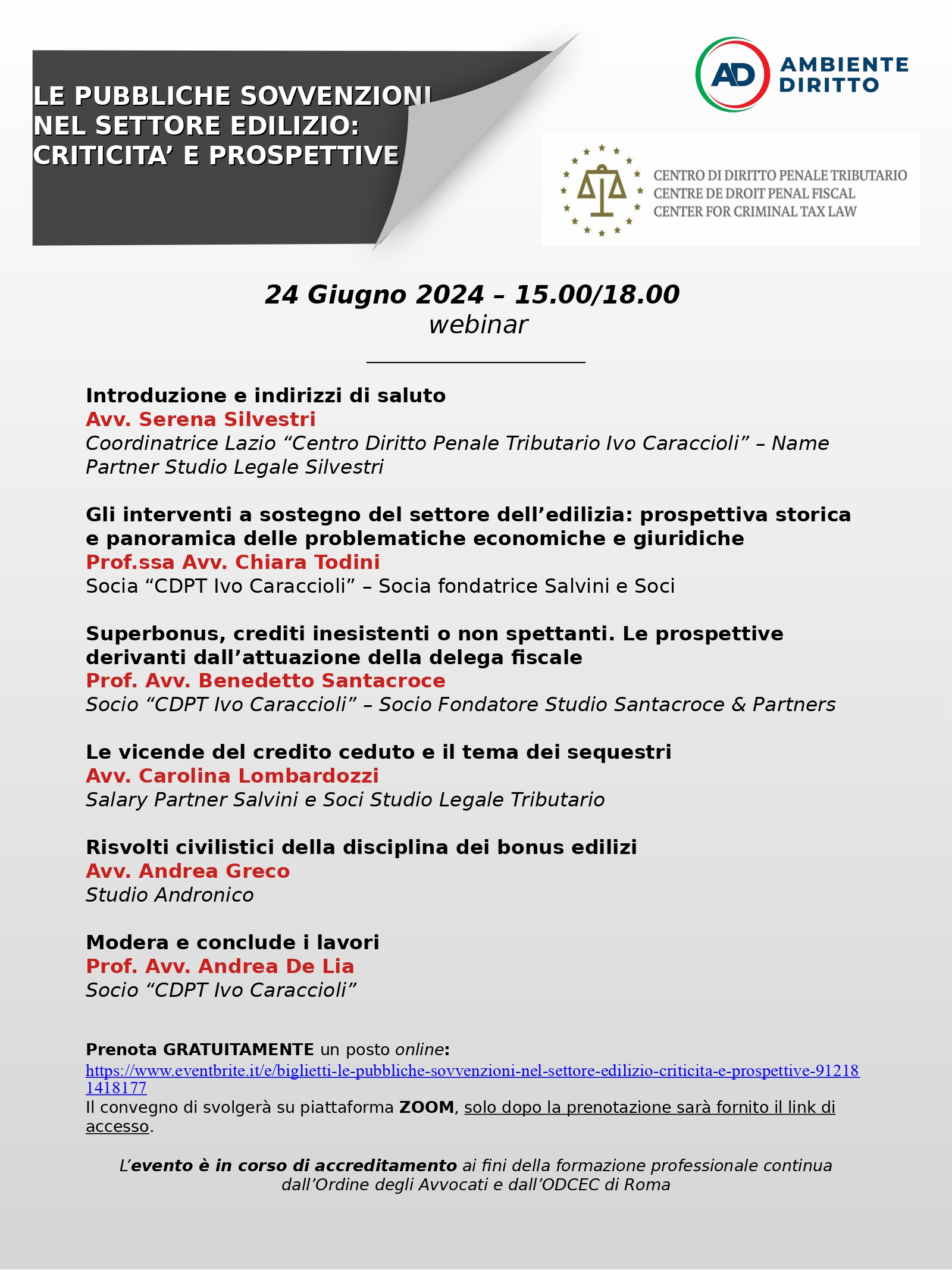

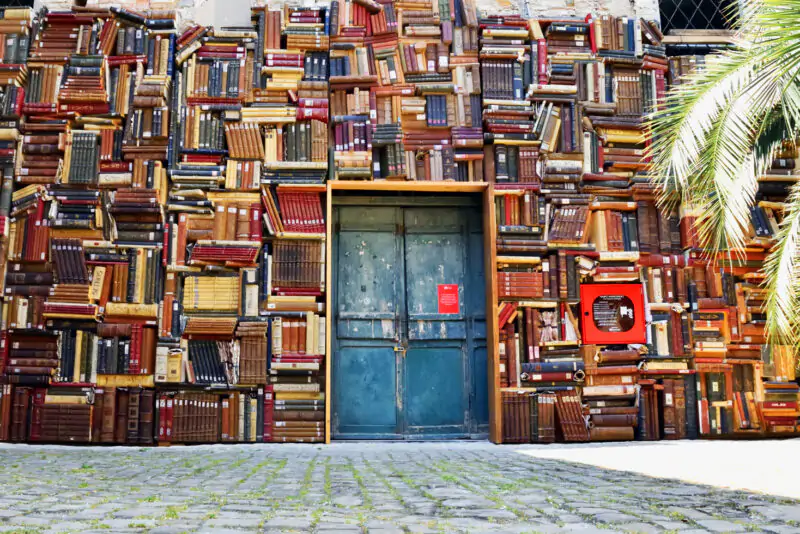 AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE
AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE