Note minime sulla regolamentazione della sigaretta elettronica in Italia: attendendo la pronuncia della Corte costituzionale
GIANCARLO A. FERRO*
1. Premessa
L’aver partecipato al gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Riccardo Polosa sulla individuazione di una regolamentazione specifica per la sigaretta elettronica [i cui esiti possono leggersi in SAITTA – FERRO – POLOSA, Achieving appropriate regulations for electronic cigarettes. In Therapeutic advances in chronic disease, 2014, 50 ss.] mi induce a condividere con la comunità giuridica alcuni spunti di riflessione per un dibattito finora rimasto appannaggio dei medici, dei media e, chiaramente, degli operatori commerciali del settore.
Credo, peraltro, che il tema abbia un suo rilievo sol che si pensi che lo scorso aprile il Tar ha sollevato questione di legittimità della “disciplina livellatrice” su cui si tornerà di qui a breve.
2. La regolamentazione della sigaretta elettronica ed i problemi di qualificazione: sguardo sintetico al diritto comparato e comunitario
Le incertezze sulla natura e sugli effetti della sigaretta elettronica si riflettono sulla regolamentazione della produzione, del commercio e della pubblicizzazione di tale dispositivo.
In alcuni ordinamenti europei (Austria, Danimarca) la sigaretta elettronica contenente nicotina è stata equiparata, integralmente o parzialmente, ad un farmaco terapeutico/dispositivo medico per disassuefazione. Pertanto, le e-cigarettes non possono essere immesse sul mercato senza averne prima valutato l’efficacia, la sicurezza e la qualità (secondo le previsioni delle direttive 2001/83/EC e 93/42/ECC).
In Norvegia, è vietata la commercializzazione e la pubblicizzazione della sigaretta elettronica con nicotina, in quanto equiparata alla sigaretta tradizionale.
In altri ordinamenti, invece, la sigaretta elettronica (con o senza nicotina) è considerata semplice prodotto di consumo non sottoposto a particolari controlli ed autorizzazioni.
In ambito comunitario, la regolamentazione della sigaretta elettronica ha dato luogo ad un serrato dibattito, che ha visto scendere in campo anche le Lobbies sostenute dai produttori di e-cig.
Ben si comprendono, infatti, i rilevanti interessi economici in gioco, sol che si pensi ai grandi investimenti effettuati per l’apertura di esercizi commerciali destinati alla vendita di questi dispositivi.
Con la direttiva 2014/40, che ha sostituito la direttiva (2001/37/CE), sono state stabilite nuove norme relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Questi comprendono le sigarette, il tabacco da arrotolare, il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, il tabacco non da fumo, le sigarette elettroniche e i prodotti da fumo a base di erbe.
L’atto comunitario si preoccupa innanzitutto di dare una definizione di e-cig. Con questo termine, infatti, si “indica un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso”.
Sono poi previsti specifici obblighi di informazione a carico dei produttori, in tal modo proiettando anche in questo ambito il principio della maggior tutela del consumatore, che ispira le politiche comunitarie consumeristiche.
In questo quadro vanno letti gli obblighi di inserimento in ogni confezione del foglio illustrativo (bugiardino) ove fornire all’acquirente tutte le informazioni salienti sul prodotto.
Se la normativa appare stringente per quanto riguarda le e-cig contenenti nicotina, dato l’accomunamento di regime rispetto a tutti i prodotti derivati dal tabacco, la disciplina comunitaria non trova applicazione, invece, per le sigarette elettroniche c.d. “medicinali” (assoggettate alla direttiva 2001/83/CE) o per quelle che si qualificano come presidi medici (sottoposte alla direttiva 93/42/CEE).
Tra gli obiettivi della direttiva vi è pure quello di incidere profondamente sulla pubblicità della sigaretta elettronica, soprattutto transfrontaliera e on line.
Anche qui il livellamento sulla disciplina delle sigarette tradizionali (e, comunque, dei derivati dal tabacco) è evidente.
3. Gli interventi restrittivi del legislatore italiano
L’Italia non ha ancora adottato una specifica regolamentazione sulla commercializzazione della sigaretta elettronica.
Tale vuoto normativo non potrebbe essere colmato sic et simpliciter dalle discipline in materia di produzione e vendita del tabacco, in quanto non tutte le sigarette elettroniche contengono tabacco. Non sarebbe, altresì, risolutivo il richiamo alla normativa vigente in materia di prodotti medicinali per uso umano e di dispositivi medici (cfr., in particolare, le direttive 2001/83/EC e 93/42/ECC). In tali ipotesi, la sigaretta elettronica andrebbe considerata, infatti, alla stregua di un farmaco terapeutico contro la dipendenza da nicotina e la commercializzazione potrebbe avvenire solo previo esperimento dell’iter autorizzativo previsto dalle vigenti normative.
Sul punto, si segnala una nota del Ministro della Salute (febbraio 2010), con la quale si chiedeva ai produttori di sigarette elettroniche di evidenziare su tutti i prodotti la concentrazione di nicotina e di apporre i necessari simboli di tossicità.
Con ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011 (reiterata il 28 settembre 2012) è stato vietato l’acquisto, da parte dei minori di anni 16, di e-cigarettes contenenti nicotina.
Il divieto è stato giustificato – in applicazione del principio di precauzione – dalla mancanza di evidenza scientifica circa la non pericolosità per la salute umana dei dispositivi in questione.
Nell’agosto 2013 il Parlamento italiano ha approvato la legge di conversione (9 agosto 2013, n. 99) del decreto legge n. 76 del 2013 (meglio noto come “decreto del fare”).
Con discutibile previsione, l’art. 11, comma 22, del predetto decreto aveva equiparato dal punto di vista fiscale le sigarette elettroniche alla sigaretta tradizionale. Invero, a far data 1 gennaio 2014, “i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchè i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, (avrebbero dovuto essere) assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico”.
Tale disposizione, come vedremo, è stata oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Tar Lazio.
Anche la commercializzazione della e-cig è stata sottoposta alla preventiva approvazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. La vigilanza (sulla commercializzazione) è stata affidata all’Amministrazione finanziaria.
Il legislatore ha poi previsto che in attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti in questione, la vendita è consentita altresì – in deroga all’articolo 74 del d.p.r. 1074/58 – per il tramite delle rivendite autorizzate di tabacchi lavorati (vedi, da ultimo, il reg. Min. ec. e fin. n. 39 del 2013).
Ad integrazione di quanto previsto nel decreto, in sede di conversione, è stato inserito un emendamento all’art. 11, comma 23, a tenore del quale le sigarette elettroniche sono qualificate “succedanei dei prodotti da fumo” e, come tali, sottoposte allo stesso regime in tema di pubblicità. Più precisamente, il legislatore ha previsto che anche alle e-cig. si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonche’ di tutela della salute dei non fumatori.
Il quadro normativo qui brevemente tracciato suscita talune perplessità.
In particolare, sorprende che una materia così delicata e “tecnica”, meritevole di attente riflessioni, sia stata affidata alla disciplina d’urgenza contenuta in un decreto legge recante misure per il rilancio economico.
Se l’equiparazione fiscale della e-cig alle tradizionali “bionde” può trovare giustificazione nell’esigenza di “far cassa”, mal si comprende l’equiparazione ai succedanei dei prodotti da fumo e, conseguentemente, l’estensione del divieto di pubblicità anche per le sigarette elettroniche.
4. L’ordinanza del Tar Lazio di remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 62 – quater, comma 4, d.lgs. 26.10.1995, n. 504: ambigua formulazione della legge ed arbitrio dell’Amministrazione.
Ben possono comprendersi le reazioni degli operatori del settore, a fronte di una disciplina, dalla quale – soprattutto sul versante della elevata tassazione – sarebbero derivati oneri di non poco momento.
Da qui la decisione di impugnare dinnanzi al Tar Lazio (II sez.) il d.m. emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 16 novembre 2013 (recante la disciplina, ai sensi dell’art. 62 –quater, comma 4, d.lgs. 26.10.1995, n. 504 e successive modificazioni, della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo).
In particolare, i ricorrenti lamentavano l’illegittimità dell’impugnato decreto e, soprattutto, dell’art. 62-quater del d. lgs. n. 504 del 1995, sotto numerosi in profili.
Tra questi, merita particolare attenzione la censura della disposizione per irragionevolezza delle statuizioni in essa contenute. Il legislatore delegato avrebbe, infatti, così equiparato i dispositivi meccanici ed elettronici alternativi al fumo, nonché le loro parti di ricambio, ai tabacchi lavorati.
Le sigarette elettroniche, infatti, “non hanno alcuna caratteristica che possa renderle assimilabili ai tabacchi lavorati. In particolare, nessun fumo o combustione sono connessi al loro funzionamento, ed anzi, il vantaggio per chi le utilizza è proprio quello di evitare l’inalazione dei prodotti della combustione, caratteristici dei tabacchi lavorati. Le miscele impiegate sono, in alcuni casi, del tutto prive di nicotina, o, comunque, contengono detta sostanza in percentuali minime”.
Irragionevole andrebbe altresì considerato l’aggravio fiscale per prodotti di uso promiscuo (quali le batterie), i quali, ove commercializzati per finalità diverse, non soggiacciono ad alcuna tassazione al consumo.
Inoltre, a detta dei ricorrenti, la disciplina dell’art. 62-quater si sarebbe posta in contrasto con i principi di concorrenza, sanciti dalla Costituzione, dall’art. 3 del Trattato UE, dagli artt. 119 e 120 del TFUE e dal Protocollo sul mercato interno e sulla concorrenza allegato al Trattato di Lisbona del 13.12.2007; in particolare, per effetto delle nuova imposizione, le imprese italiane del settore, si sarebbero trovate in posizione di svantaggio rispetto alle concorrenti ubicate in altri Stati membri, ove vige un differente e più leggero sistema fiscale sulle e-cig.
Il Tar capitolino (con ordinanza n. 4511/2014), ritenendo infondata la questione di compatibilità comunitaria sollevata dai ricorrenti, ha invece accolto l’istanza di promovimento della questione di legittimità costituzionale avverso il citato art. 62-quater del d. lgs. n. 504 del 1995 (introdotto dall’art. 11, comma 22, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99), in relazione agli artt. 3, 23, 41 e 97 della Costituzione.
In modo condivisibile, il giudice amministrativo ha evidenziato l’intrinseca irrazionalità della disposizione che non individua in maniera oggettiva, ovvero secondo categorie tecnico – giuridiche, i “prodotti succedanei dei prodotti da fumo” colpiti dall’imposta.
Dopo aver precisato, infatti, che il bene succedaneo è per definizione un prodotto che riflette le preferenze “soggettive” dei consumatori, il Tar sottolinea un importante aspetto del rapporto tra ordinamento interno e fonti comunitarie.
Infatti, “il comparto delle sigarette elettroniche non ha ancora, nemmeno in sede comunitaria, una precisa qualificazione merceologica, né vi è una normativa di carattere tecnico alla quale l’art. 62 –quater possa, anche solo implicitamente, rinviare”.
Del tutto inconferente è stato, dunque, il richiamo della difesa erariale alla direttiva tabacco di cui abbiamo fatto sopra menzione, in quanto si trattava di norme non ancora vigenti, non self executing e, soprattutto, successive all’adozione della censurata fonte interna.
Rimane parimenti incerta, secondo il Tar anche l’individuazione dei prodotti che “consentono” il consumo dei succedanei del tabacco, “potendo, in tale generica nozione, essere ricompresa tutta una serie di beni di natura promiscua, il cui uso non è necessariamente ed esclusivamente strumentale al fumo elettronico e la cui commercializzazione, in altri settori, è del tutto libera”.
Ulteriore conseguenza dell’ambigua formulazione della norma e della mancanza di criteri atti ad individuare “con certezza le componenti della base imponibile, è la previsione di un’aliquota indifferenziata, idonea a gravare con lo stesso peso su tutta la filiera del fumo elettronico e, come detto, anche su prodotti ad uso promiscuo. Tutte le incongruenze rilevate sono dovute alla circostanza che la finalità perseguita (quella di recuperare la perdita di gettito sui tabacchi lavorati derivante dal mutamento delle preferenze dei consumatori), è stata direttamente trasposta nella costruzione della fattispecie e sostituita all’oggetto dell’imposizione”.
A ciò è stato aggiunto il rilievo che l’indeterminatezza della disposizione legislativa ha lasciato l’amministrazione sostanzialmente libera di includere (o meno) nella base imponibile qualsivoglia bene che, secondo il suo insindacabile apprezzamento, venga ritenuto idoneo a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati.
Da qui la paventata violazione non solo dei principi di eguaglianza e ragionevolezza in materia tributaria, ma anche della riserva di legge in materia di prestazioni imposte e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Inoltre, il Tar ha correttamente rilevato che l’indeterminatezza del precetto normativo lede anche il diritto di libera iniziativa economica, “in quanto gli operatori del settore si trovano nell’impossibilità di pianificare correttamente i propri investimenti e di adeguare le strutture aziendali alla nuova imposizione”.
Meno condivisibile e, forse un po’ affrettata, è invece la conclusione cui giunge il Collegio circa l’equiparazione del trattamento fiscale delle sigarette elettroniche rispetto a quello dei tabacchi lavorati, che come correttamente evidenziato dai procuratori delle parti non possono essere considerati beni oggettivamente assimilabili tra loro.
Il ragionamento del giudice amministrativo è stato condotto, infatti, nel prisma del carattere speciale dell’imposta sui consumi che, per definizione, può colpire qualunque bene che non sia già sottoposto ad accisa, e ciò anche al solo fine di incrementare le entrate del bilancio dello Stato. Del resto, secondo il Tar, “non vi è ancora una definitiva certezza scientifica circa il fatto che la sigaretta elettronica non presenti alcun rischio per la salute dell’uomo, ovvero che costituisca un presidio utile alla disassuefazione dal tabagismo”.
Una lettura che non persuade del tutto, sol che si pensi che – a prescindere dagli esiti di importanti studi clinici che sembrano dimostrare il contrario di quanto affermato dal Collegio – i dispositivi di e-cig non sono affatto classificabili in univoche categorie e dovrebbero essere sottoposti ad una disciplina che di tali differenze tenga conto.
Non si poteva, comunque, chiedere al giudice di mettere luce su un aspetto che, invece, il legislatore futuro dovrebbe tenere in massimo conto, soprattutto avvalendosi dell’importante strumento dell’istruttoria legislativa, per acquisire i risultati della miglior scienza.
5. Una provocazione finale: tasse e salute
Interessante è, invece, l’inciso inserito dai giudici amministrativi secondo cui non può sostenersi che l’aumento dell’imposta sulla sigaretta elettronica sia rispondente a preminenti esigenze di tutela della salute dei consumatori ed in una specifica declinazione del principio di precauzione [sugli aspetti critici del richiamo al principio di precauzione nell’ambito della regolamentazione della e-cig, si rinvia a Saitta – Ferro – Polosa, cit.], così come invece affermato dalla difesa erariale.
Pertanto, sembra sconfessata la “presunzione” di una funzionalizzazione dell’aumento delle imposte sul tabacco (e derivati) rispetto al diritto alla salute.
Da qui, una riflessione.
Nella maggior parte dei paesi industrializzati, l’industria del tabacco è oggetto di una doppia imposizione. Il prezzo finale è costituito – come pure i costi medi e i margini di profitto dei produttori e rivenditori – da accisa (imposta sulla produzione o di consumo) e l’IVA (imposta sul valore aggiunto).
Le ragioni di questo regime fiscale speciale sono molteplici.
Le alte tasse sul tabacco e, in primo luogo, sulle sigarette, garantiscono notevoli introiti nelle casse nazionali, atteso il carattere principalmente “anelastico” del mercato del tabacco. In questo mercato, infatti, la domanda si riduce in modo proporzionalmente inferiore rispetto all’aumento del prezzo.
Questa rigidità è dovuta, tra le altre cose, alle abitudini di consumo di sigarette. L’uso diffuso del consumo di tabacco nella popolazione porta ad una tassazione più elevata del tabacco rispetto ad altre attività. Gli Stati, in questo modo, assicurano all’erario un gettito importante.
I proventi della tassa sul tabacco contribuiscono, così, al finanziamento della spesa pubblica.
Tale notazione di principio va altresì collegata ad altra finalità connessa all’aumento della tassazione sui prodotti da fumo.
Gli Stati, infatti, ricorrendo a tasse elevate sui tabacchi lavorati mirano (così si dice) a scoraggiare il consumo di un prodotto nocivo per la salute pubblica. La politica finanziaria è, in questo modo, coordinata con la politica di sanità pubblica.
In questo contesto, la tassa è utilizzata per ridurre le esternalità negative associate (o costi sociali) del fumo: aria malsana in luoghi pubblici, danni alla salute causati dal fumo passivo, costi futuri a carico del sistema sanitario nazionale per il trattamento delle persone affette da malattie correlate al fumo ecc.
Questi principi sono chiaramente enucleati nell’art. 6 (prezzi e misure fiscali per ridurre la domanda di tabacco) della Convenzione quadro sul controllo del tabacco adottati dall’OMS nel 2003 a norma del quale: ” 1 . Le parti riconoscono che il prezzo e le misure fiscali sono un mezzo efficace ed importante per ridurre il consumo di tabacco da vari segmenti della popolazione , in particolare i giovani . 2 . 2 . Fatto salvo il diritto sovrano delle parti di determinare e stabilire le loro politiche fiscali , ciascuna parte deve tener conto dei suoi obiettivi sanitari nazionali in materia di controllo del tabacco e adottare o mantenere , come necessario, misure che possono includere ( a) Attuazione di politiche fiscali e, se del caso, di politiche dei prezzi , sui prodotti del tabacco al fine di contribuire agli obiettivi di salute. Tali politiche mirano a ridurre il consumo di tabacco , e ( b ) vietare o limitare, se del caso, le vendite e / o importazioni da parte di viaggiatori internazionali di prodotti del tabacco duty-free”.
Questa strategia è stata adottata, ad esempio, dall’Unione Europea. Il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti del tabacco è attualmente delineato dalle direttive 92/79/CEE, 95/59/CE e 92/80EEC modificate da ultimo dalla direttiva 2010/12/UE, che delinea i principi generali e i vincoli minimi per gli Stati membri.
Ma tali meccanismi sulle politiche antifumo non sempre sono stati rispondenti alle attese.
Va osservata, infatti, l’inadeguatezza delle misure fiscali per il controllo del consumo del tabacco se non accompagnata da altre misure. Grande importanza è stata, ad esempio, riconosciuta alle strategia di packaging [spunti interessanti si possono trarre dal parere espresso nel 2011 dal Cancer Council Australia, Plain packagin of tobacco products: a review of the evidence, reperibile su www.cancer.org.au/content/pdf/CancerControlPolicy/PositionStatements/TCUCCVBkgrndResrchPlainPak270511ReEnd_FINAL_May27.pdf].
Soprattutto in tempi di crisi economica globale, l’aumento del costo delle sigarette ha portato ad una lieve erosione dei consumi. Tuttavia, alcune ricerche [per un’indagine approfondita sul mercato italiano, cfr. Lo studio interessante fatto da MARZIONI – PANDIMIGLIO – SPALLONE , analisi della elasticità della domanda nel mercato dei prodotti del tabacco in Italia, 2011, disponibile su http://static.luiss.it/RePEc/pdf/casmef/1106.pdf ed ivi riferimenti bibliografici] hanno dimostrato che i consumatori abituali di sigarette tradizionali hanno sostituito questi con altri prodotti “correlati”.
Tra questi prodotti si segnala, innanzitutto, il tabacco sfuso da arrotolare (RYO, acronimo di Roll your own). La tassazione di tale prodotto si attesta, ormai, su livelli molto vicini a quello delle sigarette tradizionali (in Italia, ad esempio, l’accisa sul tabacco trinciato da arrotolare e sul tabacco da fumo è equiparata all’accisa sulle sigarette). Anche se il prezzo di vendita risulta inferiore rispetto a quello delle sigarette tradizionali, per i minori costi di produzione e per la diversa base su cui l’accisa viene calcolata.
Il consumatore, però, non smette di fumare ma ricerca alternative meno costose rispetto alla sigaretta tradizionale.
L’effetto dell’elevata tassazione sulle sigarette, quindi, sposta l’oggetto del consumo verso altri prodotti derivati dal tabacco e forieri di danni (scientificamente provati) per la salute pubblica.
Importanti studi sul mercato del tabacco hanno, inoltre, evidenziato il pericolo che un’alta tassazione sulle sigarette (e sui prodotti derivati dal tabacco) possa causare una crescita del mercato illegale [si veda, ancora, S. MARZIONI – A. PANDIMIGLIO – M. SPALLONE, Analisi dell’elasticità della domanda nel mercato dei tabacchi lavorati in Italia, cit.].
Per evitare i costi “pubblici” delle sigarette, il fumatore potrebbe, dunque, essere indotto ad acquistare il prodotto di contrabbando.
Tali fattori dovrebbero essere tenuti in considerazione dai Governi. Coniugare fiscalità e tutela della salute pubblica è, senza dubbio, un nobile obiettivo da perseguire. Ma la politica è tanto più nobile, quanto più riesca ad essere lungimirante per le generazioni presenti e future.
Il contemporaneo paternalismo degli ordinamenti dovrebbe ragionevolmente equilibrare esigenze di finanza pubblica con primari interessi di tutela della salute pubblica.
Orbene, se è pur lecita in astratto l’elevata tassazione su determinati beni caratterizzati da domanda (tendenzialmente) anelastica, quali le sigarette ed i prodotti derivati dal tabacco, non sempre gli effetti che ne conseguono sono adeguati allo scopo perseguito.
L’elevata tassazione, infatti, può aumentare in astratto il gettito fiscale per l’erario ed al contempo può dissuadere i consumatori da abitudini dannose.
In tale strategia, si annida tuttavia un paradosso.
Immaginiamo che tale prodotto largamente consumato e fortemente tassato subisca – per effetto della tassazione e del minor reddito personale – una forte contrazione sul mercato.
Le entrate erariali diminuirebbero ma il livello di tutela della salute pubblica così raggiunto sarebbe formalmente più elevato.
L’equilibrio tra i due interessi coinvolti non può dirsi così raggiunto.
L’intervento nel mercato da parte degli Stati, attraverso la tassazione di determinati beni, può dirsi ragionevole nella misura in cui sia, al contempo, “correttivo” delle abitudini del consumatore.
L’aumento della tassazione su un prodotto di largo consumo ma altamente dannoso per la salute individuale e pubblica dovrebbe, in altri termini, accompagnarsi a strategie politiche che possano realmente coniugare esigenze di bilancio e tutela della collettività.
Il fenomeno crescente dell’utilizzazione della e-cig può fornire un utile esempio della tesi qui prospettata.
Imporre una tassazione uguale a quelle vigente sulle sigarette tradizionali è frutto di politiche poco lungimiranti. Tali politiche non colgono, infatti, il potenziale positivo economico e sociale insito in questo nuovo fenomeno collettivo.
Partiamo dal presupposto che la E-CIG non è una sigaretta tradizionale, non è sic et simpliciter un prodotto derivato dal tabacco. Non produce – secondo lo stato attuale dell’evidenza scientifica – i tradizionali danni collegati al tabagismo.
La E-CIG può essere vista come un’alternativa valida al fumo tradizionale e non può escludersi che possa rappresentare un ausilio per smettere di fumare (o per fumare meno).
Ciò anche in considerazione del fatto che il fumatore abituale vede nella sigaretta elettronica un continuum “comportamentale” rispetto alla sigaretta tradizionale (basti pensare, a titolo di esempio, alla medesima gestualità utilizzata).
Tale dato dovrebbe essere tenuto in debito conto dalle politiche pubbliche che, come detto, mirano a conciliare fiscalità e tutela della salute.
In un mercato che vedrebbe contratto il consumo delle sigarette tradizionali e, al contempo, la riduzione del gettito erariale, una diversa e più leggera tassazione della E-CIG potrebbe sortire importanti effetti sulla politica di bilancio e sulla health policy.
Infatti, all’alta tassazione sui prodotti tradizionali da fumo farebbe da contraltare la diversa e meno incisiva tassazione su un prodotto meno dannoso ed economicamente più accessibile.
In tal modo, dissuaso dal prezzo elevato della sigaretta, il fumatore tradizionale sarebbe indotto a sostituire la sigaretta non già con altri prodotti da fumo derivati dal tabacco (es, RYO) ma con un prodotto maggiormente innocuo e più “affine” – nell’immaginario del fumatore – alla sigaretta.
L’intervento pubblico sul mercato sarebbe, così, di natura “correttiva” e coniugherebbe fiscalità e tutela della salute.
Invero, il gettito inferiore derivato dal minor consumo di sigarette potrebbe essere ampiamente compensato dagli introiti erariali costituiti dalla tassazione sul prodotto di consumo “e-cig”, nonché dal reddito dell’intera filiera coinvolta (produttori, rivenditori etc…).
Al contempo, non ne risulterebbe trascurato l’obiettivo di dissuasione dal fumo, così come fissato dalla già richiamata Dichiarazione quadro dell’OMS.
* Ricercatore di Diritto costituzionale nell’Università degli studi di Catania.
AmbienteDiritto.it – Rivista Giuridica Telematica – Electronic Law Review – Via Filangeri, 19 – 98078 Tortorici ME – Tel +39 0941 421391 – Tel. +39 0941 430270
Fax digitale +39 1782724258 – Mob. +39 3383702058 – info@ambientediritto.it – Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 – ISSN 1974-9562



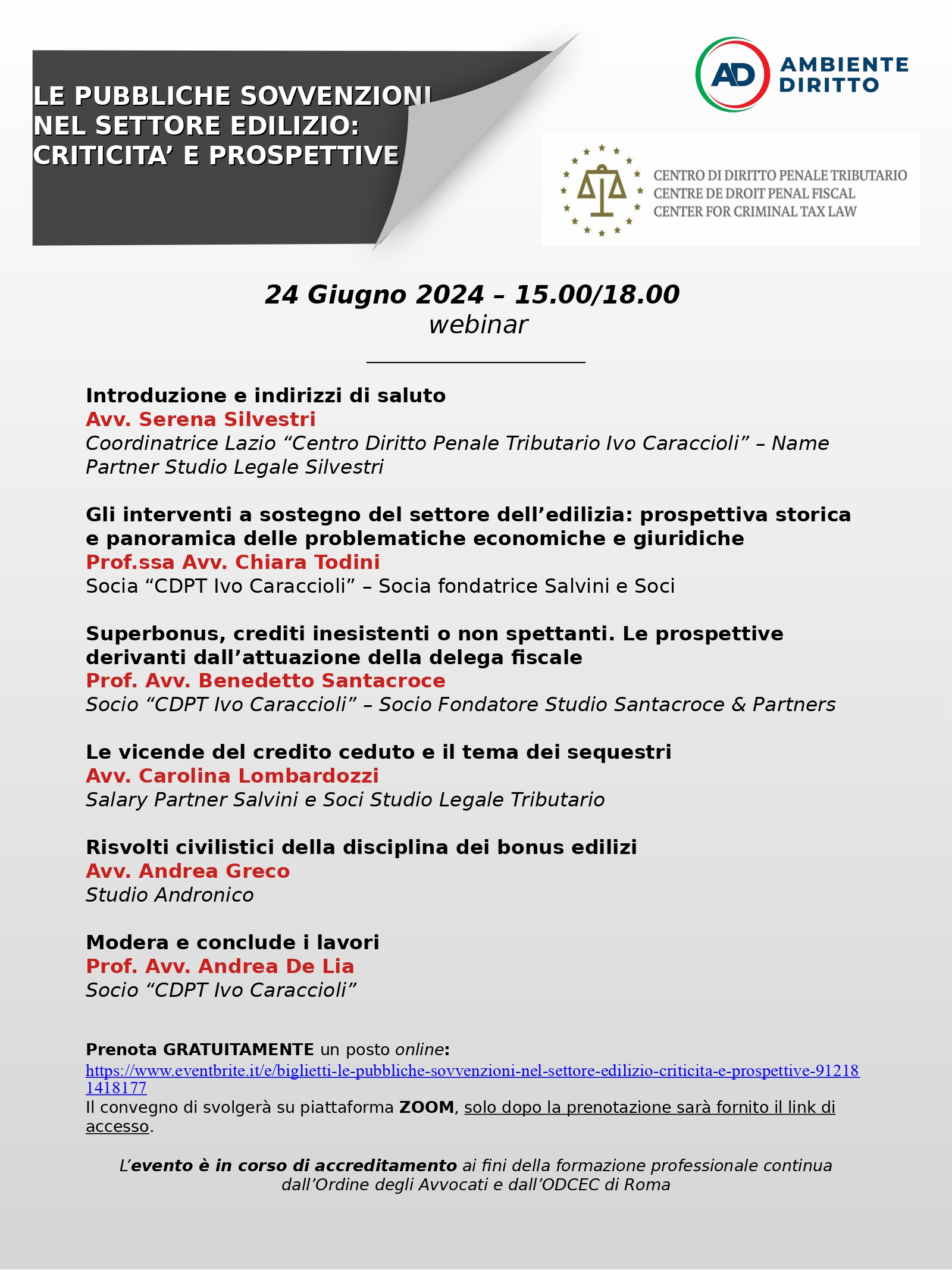

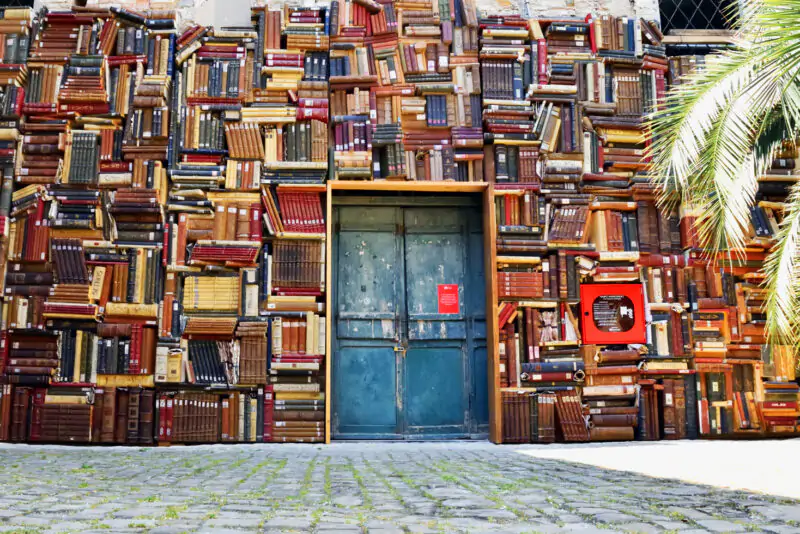 AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE
AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE