Qualificazione giuridica dei contratti per lo sfruttamento dell’energia eolica
ALESSANDRA DE MESTRIA
SOMMARIO: 1. Brevi note introduttive. 2. Gli istituti giuridici caratterizzanti il rapporto d’affari. 3. Qualificazione giuridica del rapporto contrattuale: negozio misto, complesso o collegato?
1. Gli importanti cambiamenti climatici del nostro Paese, ormai sempre piú preoccupanti, sono essenzialmente causati dalle emissioni di gas ad effetto serra.
Un rimedio a tale catastrofica realtà è rinvenibile nell’espansione delle energie da fonti rinnovabili (FR).
La questione delle fonti rinnovabili compare nel nostro ordinamento con la legge 9 gennaio 1991, n. 10: “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”1 che qualifica le energie prodotte da fonti rinnovabili quali energie di «pubblico interesse e di pubblica utilità»2.
Sebbene questo primo approccio alle FR, il primo momento ufficiale in cui si è prestata attenzione alle problematiche dell’inquinamento atmosferico si è avuto con la sottoscrizione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, effettuata a Rio de Janeiro nel 1992.
Tale convenzione prevedeva la collaborazione dei Paesi sottoscrittori al fine di raggiungere quanto prima un certo livello di concentrazione di gas serra nell’atmosfera al fine di prevenire «dannose interferenze antropiche con il sistema climatico»3.
Soltanto con il Protocollo di Kyoto, ivi predisposto l’11 dicembre 1997, adottato in occasione della III Conferenza delle Parti della Convenzione di Rio, ratificato dall’Italia con la legge 1 giugno 2002, n. 120 ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005, si è cercato di concretizzare quelli che sino ad allora erano rimasti solo ideali, ponendo a carico dei Paesi degli obbiettivi vincolanti per il contenimento e la riduzione delle emissioni di gas serra nell’atmosfera.
Il Protocollo prevede una riduzione di almeno il 5% dei gas serra nel periodo 2008-2012 prendendo come indice di riferimento le emissioni registrate nel 1990.
Un’ulteriore evoluzione rispetto all’approccio sancito a Kyoto si è avuta con la firma del Protocollo “multi inquinanti – multi effetti” sottoscritta nel dicembre del 1999 a Göteborg. Infatti, grazie all’analisi ed allo studio applicato sugli effetti dell’inquinamento, si è giunti a trattare in modo integrato anche i fenomeni dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e della formazione di ozono nell’atmosfera4.
Importante, sul punto, è la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, in materia di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Tale direttiva, che ha trovato attuazione nel diritto interno con il d.lg. 29 dicembre 2003, n. 387, prevedeva che sul consumo lordo di elettricità, entro il 2010, il 25% doveva essere prodotta da fonti rinnovabili5.
Sulla scorta della previsione di Kyoto, di recente, il Parlamento Europeo, con la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 (c.d. direttiva RES)6, detta anche direttiva 20/20/20, ha imposto agli Stati membri «target obbligatori da raggiungere a livello nazionale»7 stabilendo che entro il 2020 dovrà aversi un aumento del 20% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili con conseguente riduzione del 20% delle emissioni di Co2 e che a ciò conseguirà un miglioramento del 20% dell’efficienza energetica8.
Tale direttiva, è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lg. 3 marzo 2011, n. 28, c.d. decreto Romani.
In Italia, l’energia eolica è una delle tecnologie piú mature e competitive in molte Regioni9. Tuttavia, gli impianti eolici si sono sviluppati in modo disordinato sul territorio nonostante l’esistenza di strumenti giuridici attraverso i quali si auspicava un’individuazione piú criteriata dei bacini energetici territoriali.
Tale disordine è collegato anche ai rapporti contrattuali e alle situazioni reali di godimento che si instaurano tra il proprietario del suolo, spesso un privato, sul quale le pale eoliche vengono installate e la società interessata a tale installazione.
Nel paragrafo seguente si effettuerà un’attenta analisi dell’appena menzionato rapporto contrattuale.
2. Gli impianti eolici, come già accennato, spesso vengono installati su terreni di proprietà privata e il rapporto che lega il proprietario del suolo con l’impresa interessata alla realizzazione del parco eolico è sicuramente un rapporto contrattuale che vede il coinvolgimento di vari istituti giuridici di natura privatistica quali la locazione, il diritto di superficie e la costituzione di servitù.
Poiché pensando ad un parco eolico è naturale che si pensi súbito alle grandi distese di verde e, quindi, a terreni produttivi, si potrebbe pensare che in realtà non dovrebbe parlarsi di locazione ma di affitto.
Così non è in quanto l’art. 1615 c.c. pone un vincolo affinché possa configurarsi un affitto e cioè che l’affittuario curi la gestione del bene in conformità alla destinazione economica del bene stesso.
Nel caso dell’impresa installatrice delle pale eoliche questo non avviene, in quanto destinazione economica naturale di un fondo agricolo è quello di produrre frutti naturali e non di vedersi saldare al suolo pale eoliche destinate alla produzione e commercializzazione di energia elettrica.
Questo contratto di locazione ha ad oggetto l’installazione di un bene su un suolo di proprietà altrui. Secondo le regole civilistiche dell’accessione il proprietario del fondo diventerebbe proprietario anche dell’impianto eolico se non vi fosse la previsione codicistica dell’art. 934, ultima parte, c.c., che lascia all’autonomia negoziale la facoltà di derogare a questo automatismo.
Un illustre esponente della dottrina10 ha segnalato diversi orientamenti sostenendo che:
– secondo la dottrina maggiormente legata alle reminiscenze romanistiche, soltanto il negozio costitutivo del diritto di superficie può escludere l’accessione perché, essendo il diritto di proprietà del suolo un diritto assoluto, cosí come affermato dal brocardo “quod solo inaedificatur, solo cedit”, questo può essere limitato soltanto da un altro diritto reale limitato11.
– Invece, la giurisprudenza12 ha da sempre ammesso la possibilità di ricomprendere, tra le deroghe al principio di accessione, anche accordi aventi natura ed effetti obbligatori e non reali.
L’orientamento giurisprudenziale merita in parte condivisione in quanto la nozione di “titolo” di cui all’art. 934 c.c., unitamente al principio dell’autonomia privata di cui all’art. 1322 c.c., non consentono di escludere che le parti possano derogare al principio dell’accessione a mezzo di atti negoziali aventi efficacia personale.
Tuttavia, è prassi che le parti che stipulano contratti per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili prevedano contrattualmente che l’impresa installatrice conservi la proprietà dell’impianto, probabilmente per ragioni legate allo smaltimento di questi rifiuti speciali, costituendo un diritto di superficie con concessione ad aedificandum del proprietario del terreno all’impresa installatrice.
Il diritto di superficie, come già accennato, è un altro istituto giuridico che caratterizza il rapporto contrattuale in esame.
Per quanto il diritto di superficie sia un diritto reale di godimento, la concessione ad aedificandum ravvisabile nel contratto in esame ha suscitato incertezze interpretative in ordine alla sua natura. Infatti, alcuni , ravvedono in tale concessione una mera relazione di natura personale tra dominus e superficiario che trova la sua fonte e la sua disciplina in un rapporto obbligatorio non soggetto a sacralità, altri14, invece, ritengono che sia un diritto reale e non personale.
Anche l’orientamento giurisprudenziale ha mostrato incertezze. Si rinvengono, infatti, pronunce che favoriscono la concezione personalistica15 ed altre che condividono quella di realità16.
Come sappiamo il rapporto obbligatorio è connotato dalla relatività in contrapposizione ai diritti reali che invece sono diritti assoluti17.
Nel caso di specie il diritto di superficie con concessione ad aedificandum è da ritenere un diritto reale perché opponibile erga omnes e perché, come condiviso dalla dottrina18, in caso di inadempimento dell’impresa installatrice, il superficiario potrà ottenere, oltre ad un risarcimento danni, anche la restitutio in integrum, possibilità, quest’ultima, che sarebbe esclusa se fossimo difronte ad un contratto ad effetti obbligatori e non reali
In passato, si era ritenuto che la restitutio in integrum non poteva considerarsi un valido indice della realità del diritto, dal momento che il ripristino dello stato dei luoghi potrebbe avere natura obbligatoria trovando la sua fonte in una clausola contrattuale19. A ben pensarci, questa previsione è effettivamente riscontrabile nei contratti che le imprese installatrici stipulano con i proprietari dei fondi.
In questo scenario di incertezza giuridica, la Suprema Corte non si è risparmiata di pensare che il diritto scaturente dalla concessione ad aedificandum non si può qualificare in maniera categorica e definitiva. Infatti, in alcune pronunce20 si legge che si possa costituire a volte un diritto reale, altre volte un diritto personale, a seconda che l’opera edificata al momento della cessazione del rapporto, sia destinata a tornare nella disponibilità del concedente (nel qual caso si tratterebbe di un rapporto obbligatorio) o diventi di proprietà del concessionario (in quest’altra ipotesi si tratterebbe di diritto reale).
Queste pronunce giurisprudenziali aderiscono a quella dottrina21 che già in passato aveva individuato nella temporalità del diritto il criterio qualificativo.
Poiché nel caso di specie non siamo difronte ad una concessione a tempo determinato, in quanto la durata della concessione non è limitata alla durata del rapporto locativo, la tesi della realità è quella da avvalorare.
Altro istituto che si configura in un contratto per l’installazione di impianti eolici è quello della servitù.
La servitú è un diritto reale di godimento, tale in quanto contrassegnata dal requisito della predialità sia dal lato attivo che da quello passivo, come risulta dalla «norma definitoria» (art. 1027 c.c.)22.
Si differenzia dalla proprietà e dagli altri diritti reali di godimento per la specialità del suo contenuto. Infatti, non è soltanto un diritto reale immobiliare, ma è anche un diritto prediale (dal latino praedium = fondo) in quanto serve all’utilità fondiaria di un altro immobile.
Nel caso in esame trattasi di servitú volontaria costituita mediante contratto.
Per la costituzione di questo tipo di servitú non è richiesto l’uso di formule sacramentali, ma è sufficiente che il testo del contratto, o la formulazione della relativa clausola23, consenta di determinare con certezza il fondo dominante, quello servente e l’oggetto in cui consiste l’assoggettamento dell’uno all’utilità dell’altro24.
I contratti costitutivi di servitú sono soggetti a trascrizione in virtú dell’art. 2643, n. 4., c.c. (lo erano anche sotto l’impero del Codice civile previgente ai sensi dell’art. 1932, n. 2, c.c.). Spetta al proprietario del fondo dominate provvedervi, perché è l’unico interessato a che il diritto sia al riparo dagli atti dispositivi dei terzi dello stesso concedente, su cui incombe esclusivamente l’onere di rispettare il vincolo di asservimento concesso e di impegnare i suoi aventi causa a rispettarlo.
La servitú non trascritta, invece, è vincolante per il terzo acquirente del fondo servente se è chiaramente indicata nel titolo con cui la proprietà dell’immobile gravato è stata trasferita al medesimo25, oppure se viene richiamata la situazione dei luoghi in modo tale da far, indirettamente, ma inequivocabilmente, apprendere al terzo acquirente della sua esistenza26.
Nel caso di specie, potrebbe non essere necessaria la trascrizione trattandosi di una servitù apparente, visto l’evidente ingombro dell’impianto, ma il contratto viene comunque trascritto trattandosi di locazione ultranovennale che, invece, la richiede.
In tema di servitú, sorge una problematica conseguente all’eventuale installazione di una pala eolica in una posizione di attiguità con un fondo di proprietà di terzi. Poiché gli aerogeneratori sono strutturalmente composti da pale molto grandi, queste, inevitabilmente, invadono l’area del fondo contiguo. Si è parlato a riguardo di «servitú di sorvolo del fondo altrui»27. A questo riguardo ci si è chiesti se tale gravame per il fondo del terzo fosse legittimo e, in caso di risposta positiva, a quale titolo.
È stato investito della questione dapprima un Tribunale Amministrativo pugliese, dopo il Consiglio di Stato.
Il TAR pugliese28 ha ritenuto che la costituzione coattiva di servitú di sorvolo del fondo altrui a mezzo delle pale di un aerogeneratore, non è contemplata tra quelle previste dalla legge in materia e, dunque, non può essere costituita con atto amministrativo perché vi osta il principio della tipicità delle servitù, secondo cui la natura eccezionale delle previsioni che consentono di limitare la proprietà privata restringe ai casi espressamente previsti la possibilità di determinare un aggravio per il fondo servente a vantaggio del fondo dominante.
Il Consiglio di Stato29, invece, ha riformato detta sentenza rispondendo al quesito: «È consentito all’autorità amministrativa costituire una servitú di contenuto non previsto specificatamente nell’ordinamento, ma indicato nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitú al di fuori delle fattispecie tipiche previste dal Codice civile o da leggi speciali?».
A tal proposito il Collegio ha chiarito che per risolvere il quesito non ci si deve soffermare sulla disciplina civilistica prevista per la costituzione di servitú volontarie o coattive tra privati, bensí sui regimi espropriativi speciali che trovano in apposite leggi la loro disciplina specifica e la cui configurazione è prevista dallo stesso Codice civile. Infatti, l’art. 834, comma 2, c.c. prevede che: «Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali».
Ricordiamo che la l. n. 10 del 1991 definisce l’energia prodotta da fonti rinnovabili «di pubblico interesse e di pubblica utilità», da ciò la possibilità di applicare agli impianti eolici le norme speciali che portano a giustificare la costituzione della servitú di “sorvolo”.
Le norme di settore che interessano si rinvengono:
– nell’art. 43, comma 6 bis, del d.P.R. 8 giugno 200130, n. 327 che espressamente consente l’imposizione di servitú coattive in favore di «soggetti privati o pubblici titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua ed energia»;
– nell’art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991, che dispone «l’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3» (tra le quali è compreso il vento) «è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche»;
– nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, analizzato nel capitolo precedente.
Se non si ammettesse la costituzione di servitú, anche speciali, pur di poter esercitare un servizio di interesse generale, si dovrebbe ricorrere all’esproprio del diritto di proprietà con effetti sicuramente piú incisivi a scapito del terzo coinvolto.
In tal caso, il favor legis dell’ordinamento per la produzione da fonti rinnovabili, sarebbe frustrato da un’interpretazione restrittiva del concetto di tipicità.
Il Collegio, inoltre, richiama l’art. 1056 c.c. in base al quale «ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia». Questo richiamo è finalizzato ad evitare che in caso di innovazione tecnologica idonea a consentire la produzione di energia elettrica, nonché il suo trasferimento in modo diverso da quello tradizionale, il legislatore definisca di volta in volta le modalità di costituzione di esercizio della servitú di sorvolo dell’area interessata.
Sul punto la dottrina31 ha mosso delle critiche. Infatti, ha ritenuto la pronuncia del Collegio «troppo diretta a realizzare un interesse pubblico fuori dalla normale portata, considerato che gli impianti in questione non hanno ancora determinato vantaggi considerevoli in termini di risparmio energetico e di produzione di energia».
A tale osservazione si potrebbe obbiettare, che, comunque, si sta già guadagnando in termini di salubrità, la quale è sicuramente un interesse pubblico. Inoltre, se si dovesse negare la possibilità di costituire tali servitú si ostacolerebbe l’installazione degli impianti con conseguente regresso delle energie rinnovabili, circostanza sicuramente contraria all’interesse pubblico.
3. Nel paragrafo precedente abbiamo visto che il contratto di concessione per l’installazione di un impianto eolico è caratterizzato dalla coesistenza di diversi istituti privatistici.
La possibilità di stipulare un contratto siffatto è estrinsecazione di quell’autonomia contrattuale normativamente prevista dall’art. 1322 c.c.
È nell’autonomia negoziale che trovano la loro fonte i contratti c.d. atipici quale sicuramente è il contratto che si sta esaminando con il quale, le parti, nell’esplicazione della loro autonomia negoziale, hanno dato vita ad un negozio giuridico composto.
La nozione “negozio giuridico composto” evoca tre tipologie contrattuali: quelli collegati, quelli misti e quelli complessi.
I contratti collegati sono caratterizzati da una pluralità di negozi, e quindi da una pluralità di cause, tendenti tutti ad un unico scopo finale32.
Individuare la pluralità negoziale non è sempre agevole, spesso si incorre nella difficoltà di comprendere se si tratti davvero di pluralità di negozi o se si tratti semplicemente di un contratto unico atipico. La linea di demarcazione a volte è talmente labile che si creano delicati problemi di qualificazione33.
A complicare l’indagine dell’interprete ha contribuito la giurisprudenza, che ha anche affermato che la pluralità delle scritture non esclude a priori l’unità del negozio34, affermando che la distinzione tra contratti collegati e contratto unico non può desumersi dalla mera unità o pluralità dei documenti contrattuali, o dalla contestuale stipulazione dei diversi negozi, ma bisogna guardare agli interessi conseguiti e al loro collegamento funzionale e teleologico35.
La dottrina36 ritiene che il collegamento negoziale evochi l’antico brocardo simul stabunt, simul cadent, in deroga al principio di conservazione degli effetti contrattuali37.
Comprendere come tale principio possa influire sulle vicende giuridiche dei contratti collegati è un problema piuttosto complesso che la dottrina ha cercate di risolvere offrendo diverse soluzioni interpretative38.
Secondo una prima tesi, il contratto collegato ad un contratto risolto o nullo o annullato o rescisso sarebbe inutile39, ma è stato obbiettato che, poiché l’inutilità non è una categoria giuridica, sarebbe più corretto parlare di eventuale inefficacia del contratto collegato40.
Altra dottrina, pur riconoscendo che il contratto collegato resta valido, si esprime in termini di impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta nel contratto collegato41.
Infine, non è mancato chi si è basato sul meccanismo condizionale: il contratto collegato produrrà effetti a condizione che l’altro contratto sia efficace42.
La prima tesi non è condivisibile in quanto verte su un elemento (l’inutilità) giuridicamente irrilevante.
Alla seconda tesi si obbietta che l’efficacia di un contratto non può dipendere dalla validità di un altro contratto dal quale, seppur collegato, è comunque indipendente. Si è visto come l’indipendenza sia proprio elemento caratterizzante e distintivo di questa tipologia di contratti.
La terza tesi, invece, sembra voler trovare ad ogni costo un meccanismo che giustifichi l’applicazione del brocardo effettuando una forzatura interpretativa dell’impossibilità sopravvenuta di prestazione.
Più razionale sembra la tesi che rende la condizione strumento di interdipendenza tra i contratti in quanto trova un valido fondamento dalla possibilità concessa grazie all’autonomia contrattuale di apporre condizioni. Infatti, esistendo l’autonomia contrattuale, le parti possono liberamente condizionare l’efficacia di un contratto (nella specie quello collegato), all’efficacia di un altro.
Anche questa tesi ha trovato degli oppositori. Si è obbiettato, che poiché il contratto collegato si caratterizza per la presenza di più cause che rendono ciascun negozio dotato di una propria individualità43, non si può ritenere che un elemento accidentale (la condizione) possa prevaricare su un elemento essenziale (la causa) snaturando questo tipo contratto che da indipendente diventerebbe dipendente.
Sulla scorta di quanto detto si può escludere che il contratto stipulato per l’installazione di pale eoliche sia un contratto collegato in quanto, non solo si costituisce di un unico documento contrattuale, ma, soprattutto, sorge per un’unica causa: l’installazione delle pale eoliche. Solo per questo motivo il terreno viene locato, solo perché trattasi di un impianto eolico viene concesso un diritto di superficie con concessione ad aedificandum, solo per le caratteristiche strutturali delle pale eoliche sorge la servitù di sorvolo.
Escluso il contratto collegato, esaminiamo se è possibile qualificare il contratto oggetto di studio come un contratto complesso o un contratto misto.
Nei contratti complessi si ha un’unica causa che incide talmente tanto sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni da renderle «organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico»44. Caratteristica del contratto complesso, che lo differenzia dal contratto misto, è che nessuno dei negozi che lo compongono prevale sugli altri. Nei negozi misti, invece, i diversi negozi che coesistono nell’unico contratto si fondono tra loro e la specifica funzione di ogni schema negoziale viene sacrificata per favorirne una ulteriore che sarà quella prevalente45.
Alcuni esponenti della dottrina ritengono che, in realtà, non esiste distinzione tra contratti misti e contratti complessi riconoscendo autonomia concettuale ai soli contratti misti, altri hanno negato l’autonomia concettuale e la configurabilità come categoria dogmatica anche ai contratti misti riconducendoli alla categoria dei contratti atipici46.
Autorevole dottrina ha anche negato che si possa ritenere che i contratti misti si caratterizzino sotto il profilo causale, contrastando quell’altra dottrina che, invece, ha definito il contratto misto un contratto in cui si ha una «fusione di cause che fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente»47.
Queste incertezze interpretative sono rilevanti in quanto impediscono di collocare un contratto nella giusta categoria48 e quindi di individuare la disciplina applicabile.
Diversamente che in dottrina, la giurisprudenza49 sembra avere le idee più chiare. Infatti, dalle pronunce giurisprudenziali si evince la tripartizione contratti collegati – contratti misti – contratti complessi.
Si segnala una pronuncia della Corte di Appello di Roma che ha definito contratti complessi «quei contratti contrassegnati dall’esistenza di una causa unica che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un’intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico»50.
La giurisprudenza51 si è anche espressa sulla disciplina giuridica applicabile ai contratti misti ritenendo che questa va individuata «in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente».
Per quanto le incertezze della dottrina siano comprensibili, si ritiene che comunque la tripartizione esistente possa ritenersi valida ed efficace essendo fondata su elementi distintivi effettivi e giustificativi della differenziazione.
Volendo, in conclusione, stabilire a quale categoria appartenga il contratto stipulato per l’installazione di pale eoliche, dobbiamo partire dall’esame della causa, che, stando a quanto si qui detto, è il vero elemento distintivo.
Poiché nella fattispecie è ravvisabile un’unica causa, l’installazione delle pale, che rende i vari negozi organicamente dipendenti l’uno dall’altro e nessuno prevalente sull’altro dal momento che se per un motivo qualsiasi l’unico intento negoziale non dovesse essere più perseguibile, nessuno degli istituti ravvisati avrebbe più ragion d’essere, allora possiamo affermare che trattasi di un contratto complesso e non misto o collegato in quanto non vi è prevalenza di un negozio sugli altri per configurarlo un contratto misto e non vi è una causa diversa per ogni negozio per qualificarlo contratto collegato.
Pubblicato il 30/12/2013 su AmbienteDiritto.it – Rivista Giuridica Telematica – Electronic Law Review – ISSN 1974-9562
1 In G.U., 16 gennaio 1991, n. 13.
2 L. MAGNANI, Procedimenti autorizzativi per la localizzazione di impianti eolici, in Giur. merito, 2008, p. 2378.
3 S. MAGLIA, Corso di legislazione ambientale, 2a ed., Milano, 2008, p. 241.
4 M. MIGIARRA, Politiche nazionali ed europee per la riduzione del livello di emissione dei gas ad effetto serra e per il raggiungimento degli obbiettivi previsti dal protocollo di Kyoto, in Riv. giur. amb., 2004, p. 131.
5 S. MAGLIA, o.c., p. 328 e p. 331.
6 In G.U., 5 giugno 2009, n. 140, p. 16 ss.
7 F. ERMACORA, Promozione dell’energia da fonti rinnovabili nell’Unione Europea. Quadro normativo, attuazine e prospettive, in Riv. giur. amb., 2011, p. 723.
8 A. DE MESTRIA, Energie rinnovabili: ostacoli e prospettive. Resoconto del convegno romano organizzato dall’Associazione Nazionale Energia del Vento, in Rass. dir. civ., 2011, p. 1012.
9 D. OLIVA, La politica energetica della Puglia: il Regolamento eolico e i Piani regolatori comunali, in Amb. svil., 2008, p. 245.
10 G. TUCCI, Impianti fotovoltaici e garanzie sui beni dell’azienda, in Riv. dir. priv., 2010, p. 42 ss.
11 L’a. cita in nota (nota 31) F. DE MARTINO, Della proprietà, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1976, p. 495 ss. Mentre sull’origine e sulla relatività del brocardo citato richiama M. PARADISO, L’accessione al suolo, in Cod. civ. Comm. Schlesinger, Milano, 1994, p. 13 ss., nonché G. GORLA, L’accessione nel diritto civile italiano, in Riv. it. sc. giur., 1931, p. 89 ss.
12 L’a. fa riferimento a Cass., 25 gennaio 1968, n. 233, in Giust. civ., 1968, p. 1044; Cass., Sez. un., 2 giugno 1984, n. 3351, in Foro it., 1984, c. 2483 ss.; Cass., 10 luglio 1985, n. 4111, in Mass. Giust. civ., 1985, p. 1267; Cass., 4 giugno 1987, n. 4887, ivi, 1987, p. 1391.
13 A. BARCA, La superficie nel codice civile, in G. CASSANO, a cura di, Proprietà e diritti reali. Questioni pratiche-operative, profili processuali e di mediazione, sistemi di tutela e profili risarcitori, III, 2011, p. 1888 ss., in particolare p. 1889; L. SALIS, Proprietà superficiaria e proprietà separata, in Riv. giur. edil., 1993, p. 1026 ss.; C. TRINCHILLO, Brevi analisi dei rapporti tra diritto di superficie ed edificio in condominio. Il diritto di sopraelevazione previsto dall’art. 1127 c..c.., in Riv. not., 2002, p. 1129, nota 36
14 G. MUSOLINO, Lo spazio aereo ed il diritto di sopraelevazione fra proprietà e diritto di superficie, in Riv. not., 2005, p. 239 ss.
15 si v. Cass., 27 maggio 1971, n. 1587, in Rep. Giust. civ., 1971, v. Superficie, n. 2; Cass., 30 novembre 1967, n. 2851, in Riv. not., 1968, p. 496; Cass., 25 gennaio 1968, n. 233, in Giust. civ., 1968, p. 1044
16 Cass., 11 febbraio 1998, n. 1392, ivi, 1999, p. 878; Cass. 29 maggio 2001, n. 7300, in Giur. it., 2002, p. 48, Cass., 07 agosto 2008, n. 21287, in Dvd Pluris Utet / Cedam
17 F. CARINGELLA, Manuale di diritto civile, III, Le obbligazioni in generale, Roma, 2011, pp. 7-8
18 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2009, p. 255
19 Cass., 21 settembre 1977, in Rep. Foro. it., 1977, voce Superficie
20 Cass., 03 dicembre 2004, n. 22757 e 20 novembre 2009, n. 24498, entrambe in Dvd Pluris Utet / Cedam
21 S. CERVELLI, I diritti reali, p. 125, Milano, 2001. L’a. richiama A. PALERMO, La superficie, in Tratt. dir. priv. Rescigno, 8, Torino, 1982, p. 3 ss. e L. SALIS, La superficie, in Tratt. dir. civ. Vassalli, IV, Torino, 1958, p. 43 ss.
22 G. GABRIELLI e F. PADOVINI, La locazione di immobili urbani, Padova, 1994, p. 6.
23 Cass., 20 maggio 2008, n. 12766, in Mass. Giust. civ., 2008, p. 765.
24 Cass., 3 luglio 2000, n. 8885 la cui massima è in www.praticalegale.it.
25 Cass., 3 febbraio 1999, n. 884, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 236 e 8 agosto 1990, n. 8038, in Rep. Foro it., 1990, voce Procedimento civ., n. 160
26 Cass. 28 gennaio 1999, n. 757, ivi, 1999, p. 186.
27 Si veda E. OLIVIERO, La servitù di sorvolo del fondo altrui: il Consiglio di Stato legittima la «servitù aerea coattiva», in Riv. giur. edil., 2009, p. 1842.
28 TAR Puglia, Bari, 29 ottobre 2008, n. 2459, in Foro amm. T.A.R., 2008, p. 2860 ss.
29 Cons. St., 12 giugno 2009, n. 3723, in Vita not., 2009, p. 875 ss.
30 Pubblicato in G.U., 16 agosto 2001, n. 189 – S.O. n. 211 (ripubblicato il 14 settembre 2001, sul n. 214 – S.O. n. 231).
31 E. OLIVIERO, La servitù di sorvolo, cit., p. 1843 s.
32 Cass., 12 luglio 2005, n. 14611, in Giur. it., 2006, p. 2064
33 G. FAELLA, Sull’eccezione di inadempimento alle obbligazioni di negozio collegato, in Foro it., 2004, c. 719
34 Cass. 30 dicembre 1959, n. 3588, in Giust. civ., 1962, p. 620
35 Cass., 15 febbraio 1980, n. 1126, in Mass. Giur. it., 1980, c. 275; Cass., 21 dicembre 1999, n. 14372, in Rep. Foro it., 2001, voce Contratto in genere, n. 242; Cass., 05 giugno 2007, n. 13164, in Il civilista, 2008, p. 95; Cass., 26 marzo 2010, n. 7305, in Guida dir., 2010, 19, 38, s.m.; Cass. 21 agosto 2012, n. 14584, ivi, 2012, 44, 68, s.m. Sul punto C. SCOGNAMIGLIO, Interpretazione del contratto e interesse dei contraenti, Padova, 1992, p. 437 s.
36 F.M. SIROLLI MENDARO PULIERI, Dal subcontratto al negozio collegato: gli effetti del collegamento sulle vicende dei singoli contratti, in Arch. civ., 2004, p. 1256
37 ID, o.c. L’a. richiama alla nota 27 A. RAPPAZZO, I contratti collegati, Torino, 1998
38 Le diverse tesi dottrinali di cui alle note seguenti, sono ricostruite da G. CARTA, Collegamento contrattuale, nesso di condizionamento reciproco e dipendenza unilaterale, in Resp. civ. prev., 2008, p. 2051 s.
39 DI NANNI, Collegamento negoziale e funzionale complessa, in Riv. dir. comm., 1977, p. 332; G. DORIA, I negozi sull’effetto giuridico, Milano, 2000, p. 90
40 G. LENER, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999, p. 59 ss e, sul punto, N. IRTI, La ripetizione del negozio giuridico, Milano, 1970, p. 185
41 Si richiama per la dottrina F. DI SABATO, Unità e pluralità di negozi (Contributo alla dottrina del collegamento negoziale), in Riv. dir. civ., 1959, p. 433 ss., per la giurisprudenza Cass., 19 ottobre 2007, n. 21973, in www.neldiritto.it
42 L’a. richiama G. LENER, nota a Cass., 3 febbraio 1993, n. 1333, in Foro it., 1993, c. 3086 ss. e G. DE GENNARO, I contratti misti. Delimitazione classificazione e disciplina dei negotia mixta cum donatione, Padova, 1934, p. 61
43 S. RUPERTO, in R. SGROI (a cura di), La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, libro IV delle obbligazioni, Milano, 2009, p. 324 ss.
44 G. FAELLA, Sull’eccezione di inadempimento, cit.
45 R. MINUTILLO TURTUR, I negozi collegati, in Giust. civ., 1987, p. 252 s.
46 ID, o.c.. L’autore richiama per i primi F. MESSINEO, A. VENDITTI, N. GASPERONI, per i secondi F. DI SABATO, Unità, cit., p. 412, citato anche da A. D’ANGELO, In tema di contratto misto, in Foro it., 1970, c. 1787
47 G. FAELLA, o.c.
48 R. SACCO, Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. trim., 1966, p. 794
49 Cass., 28 marzo 2006, n. 7074; 12 luglio 2005, n. 14611 e 21 dicembre 1999, n. 14372 in Foro pad., 2000, p. 334
50 App. Roma, 03 marzo 2011, n. 914 in Dvd Dejure
51 Cass., Sez. un., 12 maggio 2008, n. 11656 in Mass. Giust. civ., 2008, p. 700 e Cass., 12 dicembre 2012, n. 22828, in Dvd Jurisdata



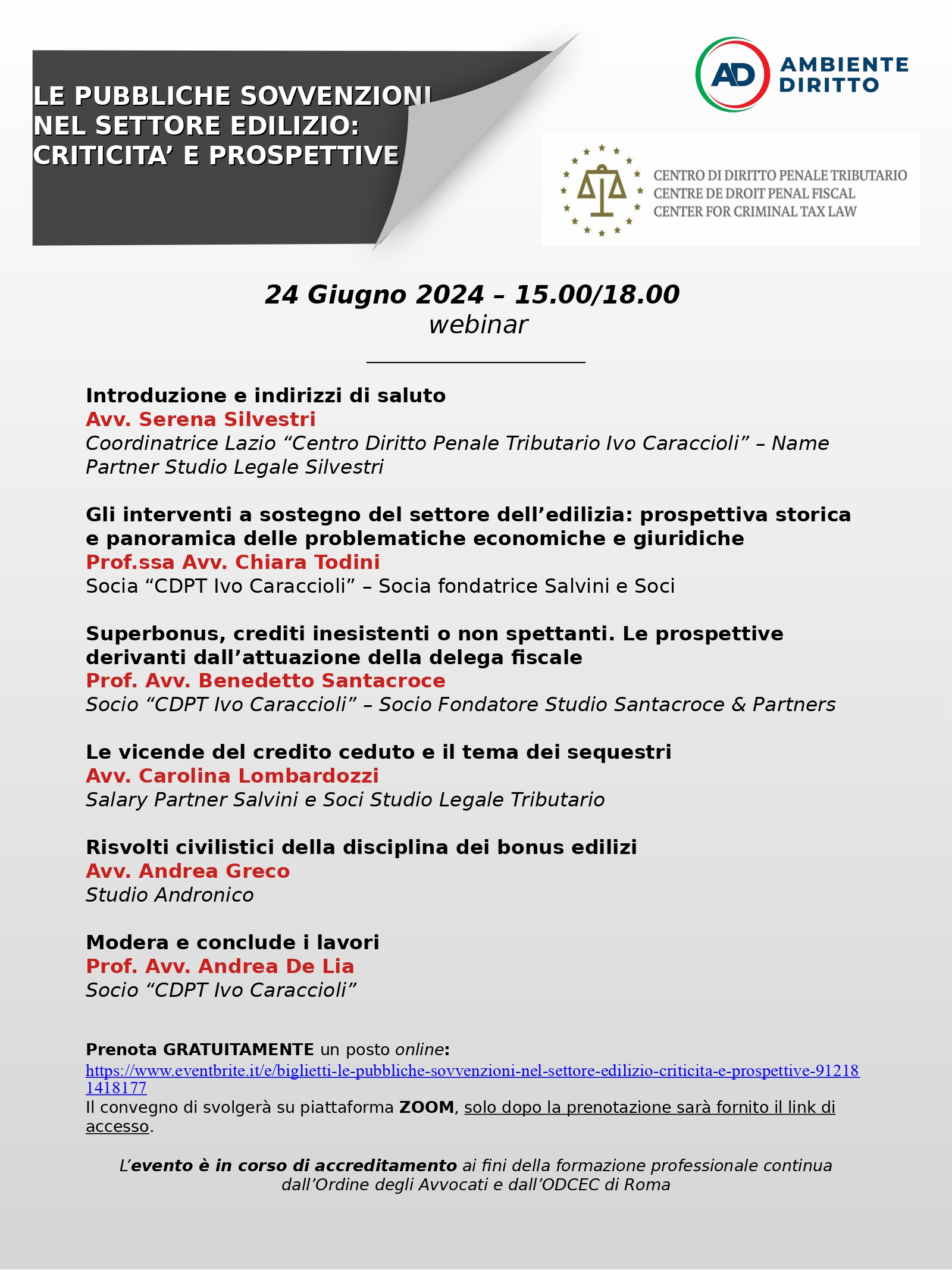

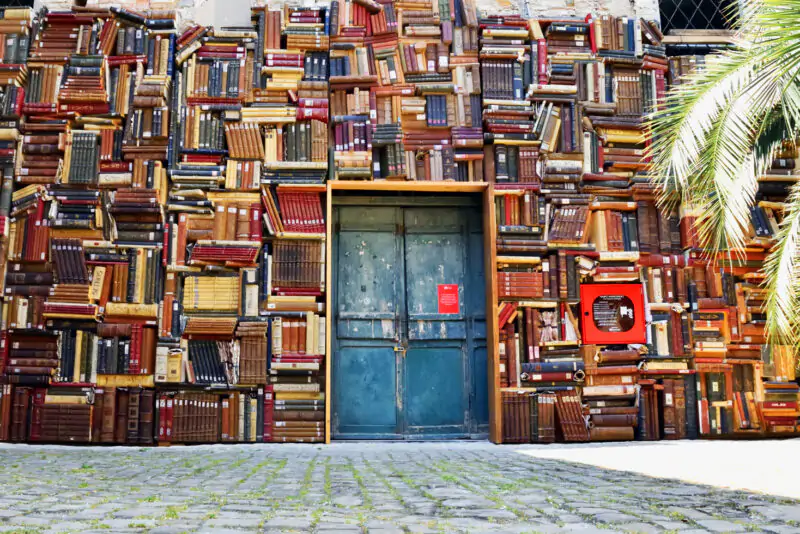 AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE
AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE