Nota a Sentenza C.d.S. del 24/05/2016 n. 2198.
Uniquique suum: IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI.
Nota a Sentenza C.d.S. del 24/05/2016 n. 2198
Simone Budelli
MASSIMA
PUBBLICO IMPIEGO – Ordinamento giudiziario – Magistrati ordinari – Trattamento economico – Applicazione art. 5, comma 4, L. n. 111/2007 – Richiesta di riconoscimento dell’anticipazione di un anno di anzianità convenzionale ai fini degli scatti stipendiali a favore di tutti i magistrati – Rigetto.
L’art. 5 comma 4, l. 30 luglio 2007, n. 111 prevede per i magistrati neoassunti la corresponsione dello stipendio “di magistrato alla prima valutazione di professionalità” avvenga dopo quattro anni di servizio (laddove, nel sistema precedente, ciò accadeva dopo cinque anni complessivi d’anzianità di servizio). Tale beneficio è stato applicato, ai fini degli scatti stipendiali, anche ai magistrati che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano ancora conseguito la precedente qualifica di magistrato d’appello (tredici anni di servizio). Chi si trova in tale ultima situazione non ha dunque titolo legittimo per ottenerne in via d’azione il trattamento retributivo corrispondente, atteso che non vi è disparità di trattamento e comunque per conseguire tale risultato, occorre che il legislatore disponga espressamente.
Autorità giudicante: Consiglio di Stato – Sezione: IV – Provvedimento: sentenza – Numero: 2198 – Data pubblicazione: 24.05.2016 – Udienza: 31.03.2016 – Presidente: Dott. Vito Poli – Estensore: Dott. Oberdan Forlenza – Oggetto: appello TAR Veneto n. 1444 del 27.11.2014 – riforma – Regione: Veneto
NOTA A SENTENZA
Uniquique suum: il trattamento economico dei magistrati
Sommario: 1. Autonomia e indipendenza della Magistratura – 2. La struttura della retribuzione dei magistrati – 2.1 La riforma introdotta dall’art 5, comma 4, della legge n. 111 del 30 luglio 2007 – 3. Le questioni proposte – 3.1 I motivi delle rivendicazioni – 4. Esiti processuali – 4.1 L’accoglimento del ricorso nella sentenza di primo grado – 4.2 Il revirement del Consiglio di Stato
1. Autonomia e indipendenza della Magistratura
Per gli antichi come ci ricorda Glaucone nel narrare la storia del famoso anello di Gige1, era urgente rinvenire il fondamento della Giustizia e il rapporto dell’uomo con il bene e il male2. Oggi, invece, come ci ricorda Sen, è forse più urgente superare le prospettive trascendentali e cercare di calare la giustizia nell’analisi delle strutture sociali esistenti e da modificare3.
Ma è evidente che nell’età dei diritti4 la giustiziabilità degli stessi diventa questione centrale per ogni democrazia e per la loro affermazione all’interno del complesso “villaggio globale”5.
Anche in una democrazia consolidata come la nostra la “questione giustizia” è sempre al centro dell’agenda politica: autonomia e indipendenza della Magistratura, divisione delle carriere, riforma del CSM, “giusto processo” (l’ossimoro è stato utilizzato anche nella modifica dell’art. 111 Cost.), potenziamento delle ADR (Alternative Dispute Resolution), solo per far riferimento ad alcune delle problematiche più dibattute.
La crisi, funzionale e organizzativa, della giustizia è infatti sotto gli occhi di tutti. I numeri sono impietosi e allarmanti6. Al di là della valutazione sulla magistratura, che varia a seconda dei periodi storici, la percezione dei cittadini in relazione al funzionamento della macchina giustizia è quello di un pericoloso mostro di carta ormai completamente fuori controllo, incapace a svolgere la sua funzione, il quale, invece di garantire sicurezza e certezza del diritto, contribuisce a diffondere paura7. Gli italiani, attendono decenni per sapere se hanno ragione o torto e soprattutto se sono colpevoli o innocenti. Gli stranieri, invece, si tengono alla larga dal nostro Paese, perché considerano l’inefficienza del servizio “giustizia”, uno dei principali fattori di rischio e di freno dell’intera nostra economia.
La questione del trattamento economico-stipendiale dei magistrati, allora, oggetto della decisione in commento, finisce per travalicare l’aspetto della stretta rivendicazione sindacale e va ad incidere sull’applicazione dell’art 104 Cost.
Come è stato evidenziato più volte dalla Corte Costituzionale “il precetto costituzionale dell’indipendenza va salvaguardato anche sotto il profilo economico”8 . Gli stipendi dei magistrati sono infatti “una guarentigia per garantire l’indipendenza”9 degli stessi e andrebbe perciò evitato che detti trattamenti economici siano sottoposti “a periodiche rivendicazioni”10. Sulla base di questi precedenti arresti giurisprudenziali della Consulta e sul presupposto che il trattamento economico dei giudici non può ritenersi, in base al principio di separazione dei poteri, nella piena e discrezionale disponibilità del Parlamento o del Governo, numerosi Tribunali amministrativi11 più di recente hanno sollevato la questione legittimità costituzionale sulla decurtazione “straordinaria” degli stipendi dei magistrati, prevista dall’art. 9, comma 22, del D.L. 78/2010, convertito con modifica dalla L. n. 122/2010.
Ciò posto, in merito alla questione in esame, che ha per oggetto l’applicazione delle nuove tabelle stipendiali introdotte dall’art. 5 della L. n. 111/2007, tuttavia, non ci si può esimere da una ulteriore valutazione: se importante è assicurare la giusta retribuzione ai magistrati togati, ancora più importante sarebbe garantire una adeguata retribuzione alle migliaia di giudici onorari che reggono, sotto un profilo almeno quantitativo, il peso della giustizia. Il loro stato di “stabile precarietà” e i loro stipendi indecorosi (specie se confrontati proprio con quelli dei loro colleghi togati), evidenziano la crisi dei pilastri su cui la giustizia dovrebbe reggersi: autonomia, indipendenza, inamovibilità12. Come non pensare, poi, anche alle migliaia di mediatori su cui il Governo punta (a parole) per alleggerire il carico delle milioni di cause pendenti nei tribunali italiani, scaricandone però il peso economico sugli sfortunati cittadini. Al di là delle valutazioni sul fenomeno della cd. privatizzazione della giustizia, è certo che oggi gli utenti del servizio giurisdizionale, oltre alle non irrilevanti spese ordinarie, devono pure sobbarcarsi anche quelle degli organismi di mediazione, i quali – a causa dei limitati poteri loro attribuiti e per quanto risulta dalle statistiche – allo stato, invece, di semplificare finiscono per aggravare ancora di più i tempi e i costi del servizio giustizia nel nostro Paese, svolgendo non un ruolo di alleggerimento, ma un’anomala funzione di sbarramento all’accesso al primario diritto alla giustizia.
2. La struttura della retribuzione dei magistrati
Per inquadrare la questione sottoposta al Consiglio di Stato pare opportuno spiegare brevemente la struttura della retribuzione dei magistrati, a partire dalle riforme intervenute a cavallo tra gli anni sessanta e settanta (l. 25 luglio 1966, n. 570, sulla nomina a magistrato di Corte d’Appello, e l. 20 dicembre 1973, n. 831, sulla nomina a Magistrato di Cassazione), con le quali sono stati eliminati i concorsi attraverso i quali, nella disciplina previgente, si progrediva tra le diverse qualifiche (magistrato di tribunale, magistrato di corte d’appello, magistrato di cassazione) ed è stata prevista la possibilità di progressione c.d. a “ruoli aperti”.
In questo sistema, i passaggi di qualifica avvenivano, a seguito di una valutazione del Csm, dopo un certo numero di anni trascorsi nella qualifica precedente: così, dopo due anni l’uditore diventava magistrato di tribunale, dopo 13 anni diventava consigliere d’appello, dopo 20 consigliere di cassazione, dopo 28 magistrato idoneo alle funzioni direttive superiori; un ulteriore passaggio retributivo, indipendente dalla qualifica, era conseguito dopo tre anni dalla nomina a magistrato di tribunale.
Ad ogni qualifica corrispondeva un distinto livello stipendiale. Le retribuzioni collegate alle varie qualifiche erano definite nella tabella allegata alla legge 18 febbraio 1981, n. 27.
Oltre che in occasione dei passaggi di qualifica, come sopra esposti, la retribuzione del magistrato era poi incrementata ogni due anni, attraverso “classi” biennali del 6% e, successivamente, attraverso “scatti” biennali del 2,5%. Tale ulteriore meccanismo di incremento stipendiale trovava (e trova tuttora) la sua disciplina nella legge 6 agosto 1984, n. 425 (“disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati”), ed in particolare nell’art. 3 della predetta norma, che stabilisce: “con effetto dal 1° luglio 1983 la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinarsi sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull’ultima classe di stipendio”.
La norma ha inoltre raccordato, la progressione stipendiale legata alle “qualifiche” (che sia pure oggi concepite essenzialmente come livelli retributivi possono continuare a denominarsi come tali, secondo la nomenclatura ripresa anche in ultimo nell’allegato 1 – tabella A della l. n. 111/2007) con quella derivante dalle classi o dagli scatti biennali, stabilendo che “al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiore successivamente al 1° luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell’importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza”.
Il principio sotteso alla disposizione è quello secondo cui, con il passaggio alla qualifica o al livello retributivo superiore, le classi o gli scatti già maturati nelle qualifiche precedenti non vengono perduti (diversamente, ad ogni passaggio di qualifica la progressione per classi e scatti ripartirebbe da zero): “l’importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza”, allorché c’è il passaggio in una nuova qualifica, viene mantenuto attraverso l’attribuzione, appunto nel livello retributivo attribuito ex novo, di un’anzianità convenzionale corrispondente alla “maggiorazione” dovuta per l’art. 5 della l. n. 425 del 1984.
Tale quadro ha subito, poi, rilevanti modifiche con il d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, recante “nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005”, e con le modifiche a questo introdotte dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, recante “modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario”.
Con tali interventi legislativi si è modificato il sistema: le qualifiche sono state rideterminate, essenzialmente come livelli retributivi e l’avanzamento tra queste diverse qualifiche è più automatico, ma condizionato e reso dipendente dall’esito delle “valutazioni di professionalità”, da svolgersi periodicamente ogni quattro anni.
2.1 La riforma introdotta dall’art 5, comma 4, della legge n. 111 del 30 luglio 2007
La principale riforma introdotta dalla L. 111/2007 consiste, dunque, nell’eliminazione dell’automatismo degli avanzamenti economici a favore dei magistrati. Tuttavia, l’esito positivo delle “valutazioni di professionalità”, che è condizione per accedere a qualifiche comportanti un livello stipendiale di più elevato ammontare, incide anche sul regime delle classi e degli scatti di stipendio di cui al citato art. 3 della l. n. 425 del 1984. Infatti, l’art. 11, comma 12, del d. lgs. n. 160 del 2006, come sostituito dall’art. 2, comma 2, della l. n. 111 del 2007, stabilisce che “la valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio”, e che “il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio”; il successivo comma 13 prevede poi che “se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso e` dispensato dal servizio”.
In buona sostanza, la disciplina della progressione economica dei magistrati viene, seppur con le modifiche sopra esposte, lasciata invariata quanto al ritmo biennale di classi e scatti, mentre è modificata l’articolazione dei livelli retributivi in qualifiche, che non si ottengono più in modo automatico. L’art. 2, comma 11, della l. n. 111 del 2007 sostituisce la tabella degli stipendi allegata alla legge n. 27 del 1981, in cui i livelli stipendiali erano rapportati, come si è detto, alla qualifica raggiunta dal magistrato. In particolare, nel passaggio tra la vecchia tabella (allegata alla l. n. 27 del 1981) e la nuova tabella (sostituita dalla l. n. 11 del 2007):
a) scompare la qualifica di “uditore giudiziario”: in base agli artt. 8 e 9 del d. lgs. n. 160 del 2006, come modificati dall’art. 1 della l. 111 del 2007, il magistrato vincitore di concorso viene immediatamente nominato “magistrato ordinario”, e svolge un periodo di tirocinio della durata di 18 mesi; per questo periodo di 18 mesi il magistrato ha la “qualifica” di “magistrato ordinario in tirocinio” (MOT); dopo i 18 mesi assume la qualifica di “magistrato ordinario”;
b) in primo luogo, dunque, la nuova tabella sopprime il primo livello retributivo, costituito dagli uditori giudiziari nei primi sei mesi dalla nomina: il primo livello retributivo previsto dalla nuova tabella è quello dei “magistrati ordinari in tirocinio”, corrispondente al secondo livello della vecchia tabella, ovvero agli “uditori giudiziari (dopo sei mesi)”;
c) il secondo livello retributivo previsto dalla nuova tabella (quello dei “magistrati ordinari” in attesa della prima valutazione di professionalità), che corrisponde sostanzialmente al terzo livello della vecchia tabella (quello dei “magistrati di tribunale”), si consegue quindi, oggi, dopo solo 18 mesi dalla nomina (cioè alla fine del periodo di tirocinio), mentre in precedenza il livello corrispondente era conseguito dopo due anni;
d) il terzo livello retributivo della nuova tabella è costituito dai “magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità”, e si consegue dopo soli quattro anni dalla nomina (e cioè, appunto, al momento della prima valutazione di professionalità), mentre il corrispondente livello della vecchia tabella (“magistrati di tribunale dopo tre anni dalla nomina”), si conseguiva dopo cinque anni dalla nomina a magistrato (due anni di uditore più tre anni di magistrato di tribunale);
e) per i successivi livelli retributivi la nuova tabella contiene invece, sempre ovviamente in relazione alla necessità di superamento delle “valutazioni di professionalità”, previsioni non dissimili da quelle della vecchia tabella, quanto ad anzianità per maturare le ulteriori qualifiche: il quarto livello retributivo della nuova tabella (“magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità”) si consegue dopo tredici anni dalla nomina a magistrato, esattamente come il corrispondente livello della vecchia tabella (“magistrati di corte d’appello”); a partire da questo momento, la progressione di carriera segue la medesima scansione della vecchia tabella, ed infatti il quinto livello retributivo (“magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità”) si consegue dopo 20 anni dalla nomina, esattamente come il corrispondente livello della vecchia tabella (“magistrati di corte di cassazione”), ed il quinto livello della nuova tabella (“magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità”) si consegue dopo 28 anni dalla nomina, esattamente come il corrispondente livello della previgente tabella (“magistrati di corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori”).
Infine, l’art. 51 del d. lgs. n. 160 del 2006, come sostituito dall’art. 2, comma 12, della l. n. 111 del 2007, fa espressamente salva la perdurante vigenza di “tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari”, e in particolare, oltre alle disposizioni in tema di adeguamento automatico di cui alla citata l. n. 27 del 1981, quelle di cui alla legge 6 agosto 1984, n. 425 e quindi “la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista”.
3. Le questioni proposte
Come detto la nuova tabella introdotta dall’art. 2, comma 11, della l. n. 111 del 2007, individua i passaggi tra le varie qualifiche, con corrispondenti livelli retributivi, in misura non perfettamente coincidente con quanto previsto dalla vecchia tabella (di cui alla l. n. 27 del 1981).
Lo scarto tra le due tabelle riguarda i primi anni di servizio, ed è essenzialmente riassumibile nella circostanza che mentre prima, per raggiungere il livello retributivo del “magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina”, occorreva avere maturato cinque anni di servizio in magistratura (due anni come uditore e tre anni come magistrato di tribunale), oggi, per la nuova tabella, il livello corrispondente (“magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità”) si consegue dopo soli quattro anni dall’ingresso in ruolo. In pratica, viene dunque anticipato di un anno il conseguimento della qualifica di “magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità” (occorrendo oggi 4 anni), rispetto a quel che accadeva in forza della vecchia tabella con la corrispondente qualifica (“magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina”, per cui occorrevano cinque anni).
Dopo tredici anni di servizio le due tabelle però si equiparano: la qualifica successiva a quella di “magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità”, corrispondente nella vecchia tabella a “magistrati di corte d’appello” ed in quella nuova a “magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità”, si consegue comunque in entrambe le tabelle dopo tredici anni dalla nomina (così come la qualifica ancora successiva, corrispondente rispettivamente nelle due tabelle a “magistrati di corte di cassazione” e “magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità”, che si consegue dopo 20 anni dalla nomina).
Tuttavia per i detrattori della riforma, il beneficio consistente nel poter maturare con anticipo di un anno la qualifica ed il livello retributivo corrispondente a “magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità”, costituirebbe una disparità di trattamento economico, rappresentando un vantaggio per i nuovi assunti, destinato a non essere più riassorbito, anche a seguito di ulteriori avanzamenti di qualifica e di livello stipendiale.
Ciò in quanto, se agli effetti del menzionato art. 5 della l. n. 425 del 1984 l’anzianità convenzionale che il magistrato oggi riceve nell’accedere alla qualifica di “magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità”, a titolo di “maggiorazione” per “l’importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza”, assomma pur sempre ad un anno e cinque mesi13 (come previsto, in base alla vecchia tabella), tuttavia la soppressione dell’ “uditorato”, comporterebbe un immediato ingresso in carriera e un indubbio vantaggio stipendiale per i nuovi assunti . In altri termini, il magistrato che non ha svolto l’uditorato, ha avuto accesso dopo 4 anni alla qualifica di “magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità” e può accedere con un anno di anticipo ad una qualifica e ad un livello stipendiale superiore rispetto ai colleghi che, invece, in base alla vecchia tabella, hanno conseguito tale incremento solo dopo 5 anni.
A tale obiezione dal Ministero si era evidenziato come la differenza di trattamento poteva trovare ragione nel fatto che la progressione di carriera di cui alla l. n. 111 del 2007 è legata alle “valutazioni di professionalità” e, pertanto, ad una valutazione oggi più rigorosa dell’attività del magistrato, che ben avrebbe compensato il più lungo periodo che era stato necessario per l’avanzamento ai magistrati meno giovani.
3.1 I motivi delle rivendicazioni
Per tale ragione, i magistrati chiedevano il riconoscimento del loro diritto ad anticipare di un anno la decorrenza dell’anzianità della base stipendiale già prevista per il magistrato di tribunale dopo tre anni, ed oggi prevista per il magistrato ordinario dalla prima valutazione, a favore di tutti i magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della l. n. 111/2007, avessero più di quattro anni di anzianità.
In altri termini, posto che una volta anticipato di un anno il conseguimento della qualifica e del livello stipendiale, il successivo passaggio di qualifica e livello retributivo14 si poteva conseguire dopo nove anni, (essendo comunque fissato a tredici anni dalla nomina), la questione riguardava come quantificare, in termini di classi ed aumenti biennali, questi nove anni che sono destinati ad influire in maniera duratura sulla futura progressione economica15.
Per la verità, il Ministero della Giustizia16, si era almeno in un primo tempo orientato nel senso che ai nove anni di permanenza nella qualifica e livello stipendiale di “magistrato ordinario dalla prima valutazione” (già “magistrato di tribunale dopo tre anni”), avrebbero dovuto aggiungersi il “maturato economico che si trascinava dalla precedente qualifica pari a 1 anno e 5 mesi”. In questo modo, durante la permanenza nella qualifica di “magistrato ordinario dalla prima valutazione” (già “magistrato di tribunale dopo tre anni”), maturano cinque classi stipendiali (9 anni + 1 anno e 5 mesi = 10 anni e 5 mesi), con un ulteriore effetto di trascinamento sulle ulteriori progressioni economiche di carriera.
Questa interpretazione del Ministero della Giustizia non è stata però condivisa dal Ministero dell’Economia, il quale con la nota del 21 aprile 2011, stabiliva che all’anzianità di nove anni nella qualifica di “magistrato ordinario dalla prima valutazione” (già “magistrato di tribunale dopo tre anni”) corrispondono 4 e non 5 classi stipendiali, anche e soprattutto agli effetti dell’ “importo corrispondente alle classi maturate nella posizione di provenienza” da attribuirsi, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 425 del 1984, quando si realizzi il passaggio alla successiva qualifica e livello stipendiale di “magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità” (già “magistrato di corte d’appello”).
Con l’ulteriore nota del 20 maggio 2011, il Ministero dell’Economia, sosteneva che l’ “anzianità convenzionale” (di un anno e 5 mesi) che viene attribuita all’ “atto della promozione” nella qualifica (di “magistrato ordinario dalla prima valutazione”, già “magistrato di tribunale dopo tre anni”), può valere per la progressione economica delle classi stipendiali entro tale medesima qualifica, ma non può essere invece considerata, per il computo dell’anzianità complessiva ai fini delle classi stipendiali conseguite nella “qualifica di provenienza”, una volta che si venga “promossi” alla qualifica e al livello stipendiale ancora “superiore” (ovvero “magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità”, già “magistrato di corte d’appello”).
Tale interpretazione, il Ministero dell’Economia la deduceva dall’art. 5 della l. n. 425 del 1984, là dove esso, nel parlare, per il trattamento da accordare ai “promossi” a qualifica o livello “superiore”, di “stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell’importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza”, imporrebbe per ciò solo di non considerare l’anzianità che, in tale “posizione di provenienza”, era acquisita solo come “convenzionale”, appunto come “maggiorazione” corrispondente, a sua volta, “alle classi o aumenti biennali maturati” in una qualifica o in un livello precedente ed ancora “inferiore”.
Tuttavia è veniva osservato dal Ministero della Giustizia17 l’anomalia di questa, seppur convenzionale, “anzianità”, che risultava valida ed efficace agli effetti della progressione economica per classi ed aumenti biennali, entro la qualifica di “magistrato ordinario dalla prima valutazione”, (già “magistrato di tribunale dopo tre anni”) ed invece perdeva qualsiasi effetto, nei passaggi successivi di carriera.
4. Esiti processuali
4.1 L’accoglimento del ricorso nella sentenza di primo grado
Per le ragioni sopra esposte la richiesta dei magistrati ricorrenti secondo cui, per ogni effetto di progressione economica, anche inerente al computo di classi ed aumenti biennali nella “posizione di provenienza”, ai sensi dell’art. 5 l. n. 425/1984, si dovesse tener conto dell’anzianità comunque attribuita e non solo del tempo materialmente trascorso nella qualifica o livello retributivo, veniva accolta dalla I sezione del Tar Veneto. Conseguentemente, i giudici di primo grado, ordinavano tutti i provvedimenti conseguenti per la ricostruzione della carriera e per l’attribuzione del trattamento economico. Rigettavano, invece, la domanda volta al riconoscimento di cinque, anziché quattro classi biennali, conseguente alla anticipazione di un anno, rispetto all’ordinamento previgente, nell’attribuzione della qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità.
4.2 Il revirement del Consiglio di Stato
Impugnavano la sentenza il Ministero di Grazia e Giustizia, Il Ministero dell’Economi e la Presidenza del Consiglio. Gli ultimi due eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Il primo invece nel merito sostenendo che non vi erano motivi di disparità di trattamento fra i nuovi assunti e i magistrati di più lungo corso.
I magistrati ricorrenti, dal conto loro, si costituivano presentando appello incidentale relativamente alle richieste non riconosciute dai giudici di primo grado.
I giudici di Palazzo spada, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Presidenza del Consiglio e Ministero dell’Economia, nel merito sposavano integralmente le tesi ministeriali.
Confermando quanto deciso in precedenti sentenze18, la sentenza in commento sostiene che non è possibile rinvenire una disparità di trattamento in un contesto normativo completamente mutato: prima si considerava solo il tempo maturato nella funzione, con la nuova L. n. 111/07 si era invece introdotto un sistema di avanzamento completamente diverso basato su valutazioni professionali qualitative. Essendo diversi i criteri, non sarebbe stato logico, prevedere come richiesto dai ricorrenti una norma transitoria, che avesse ricreato meccanismi automatici, addirittura più favorevoli rispetto a quelli pregressi, facendo rientrare dalla finestra quello che il legislatore aveva voluto far uscire dalla porta19 e creando, stavolta sì, una situazione di disparità di trattamento. Sul punto, il Consiglio di Stato evidenzia, peraltro, come l’applicazione del meccanismo della “temporizzazione”, previsto dall’art. 4 della l. n. 425 del 1984 non poteva essere esteso al caso di specie, in quanto contenuto in una disposizione di carattere transitorio, ‹‹recante esclusivamente le modalità di valutazione dell’anzianità maturata al 30 giugno 1983››20.
1 Secondo Glaucone (Platone, La Repubblica) se due persone, una giusta e una ingiusta possedessero l’anello di Gige (Re della Lidia), ovvero quell’anello che secondo il racconto di Erodoto, aveva la capacità di rendere invisibile chi lo indossasse, finirebbero per comportarsi allo stesso modo, ovvero agendo ingiustamente al riparo della riprovazione sociale e dal pericolo della sanzione coercitiva. In altri termini, secondo il fratello di Platone, ci si comporta correttamente solo se si è costretti, perché l’ingiustizia è più profittevole della giustizia.
2 Le questioni sollevate da Glaucone sono sempre attuali e più di recente vi ha provato a dare una sua risposta anche Philippa Foot (classe 1920), una delle figure centrali della filosofia morale angloamericana. Nel suo libro, La Natura del bene, Bologna, 2007, l’A. ha sostenuto (partendo da una visione aristotelica, ma laica e neohumeana) che le virtù, (che “hanno un ruolo necessario nella vita dell’uomo così come il pungiglione nella vita delle api” perché costituiscono le “ragioni” dell’agire umano), vincolano l’uomo al bene, secondo l’interesse e i desideri dell’agente.
3 A. Sen, L’idea di Giustizia, Milano, 2010, p. 31 e ss.. Vedi sul punto R. Chiarelli, Introduzione, in S. Budelli (a cura di), Trattato sulla media-conciliazione, vol. 1, Roma, 2012, p. 7 e ss.
4 L. Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti, Roma – Bari, 2013, p 181 e ss.
5 A. Cassese, I diritti umani oggi, Roma – Bari, 2005, p. 28 e ss.
6 Vedi sul punto M. De Paolis, Le disfunzioni del “sistema giustizia” nell’ordinamento nazionale, in S. Budelli (a cura di), Trattato sulla media-conciliazione, vol. 3, Roma, 2012, p. 7 e ss.
7 Basti pensare ai vari e fortunati films di Alberto Sordi sul problema (Detenuto in attesa di giudizio, 1971 o Un borghese piccolo, piccolo, 1977), in cui si ripropongono i temi dell’alienazione dell’uomo di fronte alla cieca e violenta burocrazia giurisdizionale, già trattati da F. Kafka nel suo romanzo incompiuto Der Process del 1914.
8 C. Cost. n. 1 del 16 gennaio 1978. Analogo concetto è stato ribadito dagli artt. 2 e 7 della cd. Magna Carta dei Magistrati approvata a Strasburgo il 17 ottobre 2010.
9 C. Cost. n. 238 dell’8 maggio 1990.
10 C. Cost. n. 42 del 10 febbraio 1993.
11 Cfr. TAR Piemonte ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale n. 846 del 28 luglio 2011 nel proc. RG 409/2011; TAR Campania – Salerno, sez. I, ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale n. 1162 del 23 giugno 2011 nel proc. RG 657/2011; TAR Veneto, sez. I, ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale n. 1685 del 15 novembre 2011 nel proc. RG 645/2011.
12 Cfr. R. Bin – G. Pitruzzella, Diritto pubblico, Torino, 2014, p. 507 (par. “Indipendenza, autonomia e inamovibilità della magistratura ordinaria”).
13 La circostanza che in ogni caso l’anzianità accordata convenzionalmente ex art. 5 della l. n. 425 del 1984, all’accesso alla qualifica di “magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità” sia sempre di un anno e cinque mesi, come per l’accesso alla qualifica di “magistrati di tribunale dopo tre anni dalla nomina”, risulta confermata anche dallo scambio di note tra il Ministero dell’Economia e quello della Giustizia, in data 10 maggio e 20 maggio 2011
14 “magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità”, nella nuova tabella, già “magistrati di corte d’appello” nella vecchia tabella.
15 Si rammenti, al riguardo del computo di classi ed aumenti biennali, che, come si è precisato più indietro, proprio e sempre in forza dell’art. 5 della l. n. 425 del 1984, all’ingresso nella qualifica di “magistrato ordinario dalla prima valutazione”, come già di “magistrato di tribunale dopo tre anni”, viene attribuita, oltre alla nuova base stipendiale, un’anzianità convenzionale, di un anno e cinque mesi.
16 Cfr. il Decreto del Direttore generale del Ministero della Giustizia del 22.10.2010 e la successiva nota dello stesso datata 10 maggio 2011.
17 Il Ministero della Giustizia nella citata nota del 10 maggio 2011, osservava tuttavia, che se all’ “atto della promozione” in una qualifica o livello stipendiale “superiore” (di “magistrato ordinario dalla prima valutazione”, già “magistrato di tribunale dopo tre anni”) è stata attribuita una “maggiorazione” ex art. 5 della l. n. 425 del 1984, espressa in un’ “anzianità convenzionale” a valere per le classi e gli aumenti biennali a venire, diventava difficile comprendere perché la medesima “anzianità convenzionale” avrebbe dovuto valere soltanto a metà, come spiegato dal Ministero dell’Economia, ovvero valere ed essere attributiva di classi ed aumenti biennali, sino a che si resti nella qualifica o nel livello ormai attribuito, perdendo invece ogni valore all’ atto dell’ulteriore “promozione” (a “magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità”, già “magistrato di corte d’appello”). Peraltro l’interpretazione data dal Ministero della Giustizia è quella che era stata fino a quel momento applicata nel passaggio dalla qualifica di “magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità” (già “magistrati di corte di cassazione”): anche qui il tempo di permanenza nella qualifica precedente (“magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità” già “magistrati di corte d’appello”) era per un numero dispari di anni, segnatamente sette ed anche qui per il computo di classi ed aumenti biennali maturati nella qualifica “di provenienza”, pure quando si trattava di calcolare la “maggiorazione” dovuta per l’art. 5 della l. n. 425 del 1984 a chi era promosso “magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità” (già “magistrato di corte di cassazione”) si teneva conto, oltre che dei sette anni, dell’anzianità “convenzionale”.
18 Altre pronunce precedenti, tutte conformi, sono: Cons. St. n. 1445 del 19.3.2015, Cons. St. n. 2451 del 14.5.2015; Cons. St. n. 603 del 19.3.2015.
19 Cfr. Cons. St., Sez. IV, 2 aprile 2002, n. 1820; id. 3 giugno 1996 n. 705.
20 Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2015 n. 1447.



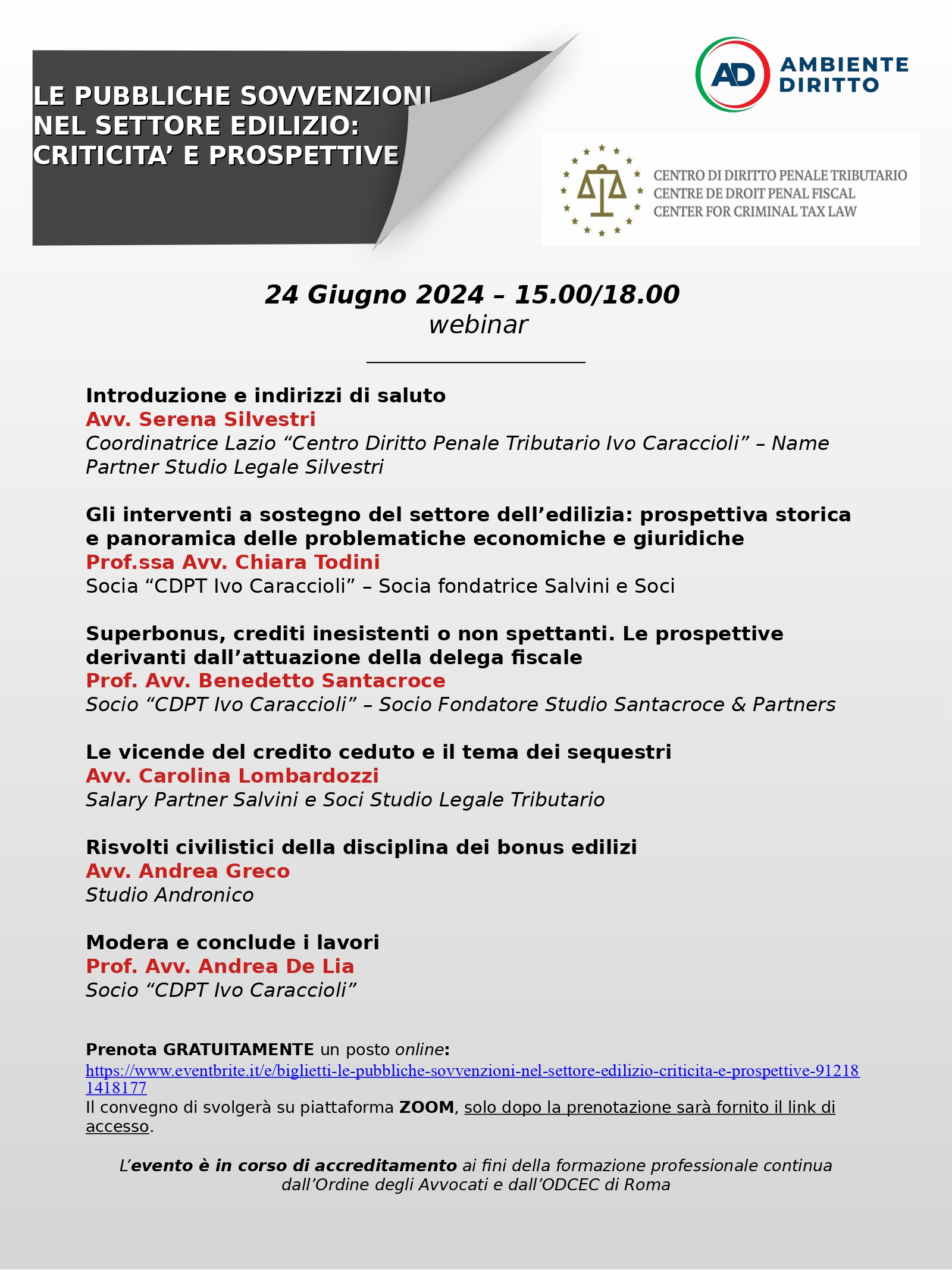

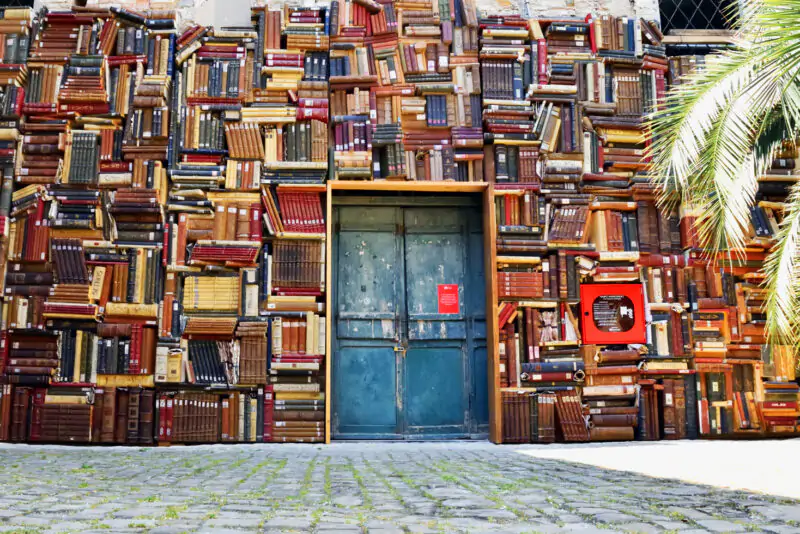 AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE
AMBIENTEDIRITTO.IT EDITORE